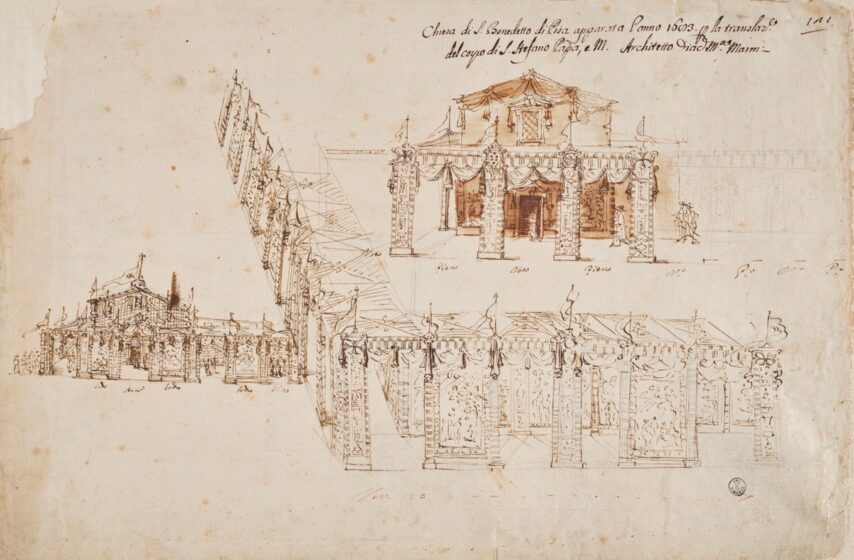Eventi in Piazza
1288
La presa del Palazzo del Popolo
Nel 1288 il conte Ugolino della Gherardesca, capitano del popolo, ebbe la peggio contro la fazione ghibellina capeggiata dall’arcivescovo Ruggieri. Come attestano fonti di poco posteriori, la futura Piazza dei Cavalieri fu il teatro sia delle iniziali trattative, sia della successiva violenta contesa armata. L’episodio si sarebbe concluso con l’incarcerazione e la morte di Ugolino nella Torre della Fame, resi eterni dalle celebri rime dantesche.
Nella continua evoluzione storica degli usi e dei significati che le comunità attribuiscono ai luoghi pubblici, nella lunga stagione medievale Piazza dei Cavalieri (un’area urbana per la quale si utilizzava in età premoderna il toponimo ‘delle Sette Vie’) è stata anche un’arena di contesa armata tra le fazioni che animavano la vita politica del Comune. L’espressione ‘prendere la piazza’, che si ritrova in alcune fonti cronachistiche antiche, indicava, per via di metonimia, l’occupazione manu militari del centro amministrativo della città e dunque il suo controllo politico. Il caso forse più clamoroso riguarda lo scontro che precedette l’imprigionamento di Ugolino della Gherardesca e dei suoi familiari. La fonte più «linguacciuta», per usare la felice espressione di Mauro Ronzani, che descrive cioè con dovizia di particolari l’episodio, è costituita dai Fragmenta historiae pisanae. Scritta probabilmente alla fine del XIII secolo, questa cronaca anonima narra gli eventi di Pisa dal 1190 al 1293 (con una coda di diversa impostazione incentrata sul periodo 1327-1336). L’unico manoscritto a tramandarla è l’Additional 10027 della British Library, mentre una copia a stampa ci giunge dal meritorio lavoro dell’erudito Ludovico Antonio Muratori che pubblica il testo nella sua opera Rerum Italicarum Scriptores. Sebbene sia difficile ipotizzare fondatamente l’identità dell’autore o l’ambiente di produzione del testo, diversi dettagli narrativi (in particolare circa le responsabilità della morte dei prigionieri) inducono a ritenere un orientamento non marcatamente ostile a Ruggieri e al fronte Ghibellino.
Nell’ottobre 1284 Ugolino viene eletto podestà, incarico che di lì a pochi mesi gli sarebbe stato attribuito in via eccezionale per dieci anni. Ad affiancarlo nel suo compito il nipote Nino Visconti, che nel 1286 assume la carica di capitano del Popolo. Dopo una coabitazione burrascosa ai vertici del comune, i diarchi scambiano i propri ruoli: Ugolino assume la stessa carica, trasferendosi nel palazzo dell’omonima magistratura su Piazza delle Sette Vie, mentre Nino diventa podestà. Il 30 giugno 1288, mentre Ugolino si trova nel suo castello di Settimo, nel contado pisano, Nino viene allontanato dalla città (con probabile sostegno dello stesso Ugolino) da una cordata ghibellina guidata dall’arcivescovo Ruggieri, che si insedia nel Palazzo del Comune. Rientrato precipitosamente, il conte comincia una delicata trattativa sui futuri assetti del governo in San Sebastiano alle Fabbriche maggiori (nel sito sul quale sorge oggi la chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri) che si protrae fino al primo luglio. Riportano i Fragmenta: «lo dicto conte, e l’arcivescovo l’autro die di calende luglio la matina funno insieme in de la chiesa di Santo Bastiano, e non s’acordonno la matina, e doveanovi tornare di po’ nona». Durante una pausa dell’incontro filtra la notizia che Brigata, nipote di Ugolino, stava cercando di aprire le porte cittadine a Tieri Bientina, genero del conte, a capo di una compagnia di mille uomini armati. I maggiorenti della fazione avversa, temendo un tradimento, ingaggiano un’aspra contesa armata.
La narrazione dello scontro si apre con una nota sonora: le campane poste sui palazzi delle due più alte magistrature suonano a sostegno delle fazioni in lotta: quella «del Popolo» nell’omonimo palazzo per Ugolino, mentre quella del Palazzo del Comune (posto in Piazza Sant’Ambrogio, nell’area dell’attuale Piazzetta Lischi, già del Castelletto) per l’arcivescovo. Gli scontri a piedi e a cavallo si dispiegano nelle vie prospicienti la piazza: San Frediano, San Sebastiano (attualmente identificabile con Via Consoli del Mare) e «l’autre vie». Lo scontro fu cruento: registrò alcune vittime illustri (tra cui il nipote dell’arcivescovo Ruggieri) e durò all’incirca mezza giornata («da di po’ nona in fine a presso a di po’ vespero»: da mezzogiorno inoltrato al tramonto). Le forze ghibelline prevalsero infine su quelle del conte, che si vide costretto a ripiegare. Asserragliato con la famiglia all’interno del Palazzo del Popolo (o Palazzo degli Anziani, con particolare riferimento all’ala di destra – per chi guarda – dell’attuale Palazzo della Carovana), cominciò così l’ultima fase del conflitto. Gli uomini fedeli a Ruggieri (secondo la cronaca di Giovanni Villani, tutto il popolo pisano) assaltarono da ultimo l’edificio «con fuoco, e per battaglia», vincendo le ultime resistenze e imprigionando il conte «traditore» con i suoi familiari.
1292
Festa dell’Assunzione
Attestata nelle delibere comunali tra Duecento e Trecento, la Festa dell’Assunzione era preceduta alla vigilia da un corteo che prendeva probabilmente le mosse dalla futura Piazza dei Cavalieri, riccamente addobbata per l’occasione, e accompagnava gli Anziani e il capitano del Popolo (massime magistrature pisane) alla Cattedrale, dove venivano recati in dono ceri.
Una delle solennità più importanti della Pisa medievale è senz’altro quella legata al culto dell’Assunta. In essa si celebra, secondo un’antica tradizione cristiana, l’assunzione al Cielo della madre di Gesù Cristo, la Vergine Maria. Le fonti che riportano con dovizia di particolari i preparativi e poi il cerimoniale delle celebrazioni sono gli Annali pisani redatti dall’erudito seicentesco Paolo Tronci, nonché una serie di documenti ufficiali conservati presso l’Archivio di Stato di Pisa e l’Archivio dell’Opera del Duomo. Lavoro meritorio della scuola storica italiana, Pietro Vigo, in un testo del 1882 poi rifuso in un volume più ampio pubblicato nel 1888, ricostruisce con acume e accuratezza questo importante frammento della vita comunale, in parte lavorando sulle fonti d’archivio, in parte recuperando la descrizione che Tronci fa della festa, ascrivendola all’anno 1292.
Come per la processione del Corpo di Cristo, anche per l’Assunta la formalizzazione da parte delle istituzioni pubbliche dello svolgimento delle due giornate di festa (la vigilia del 14 agosto e le celebrazioni vere e proprie del giorno successivo) era pervasiva. Difficile stabilire una data di inizio delle celebrazioni: è certo, tuttavia, che le delibere comunali proseguirono per tutto il XIII e XIV secolo. Con congruo anticipo (vi è tuttavia divergenza sul punto tra le fonti) le celebrazioni erano annunciate attraverso un bando pubblico. Del compito erano incaricati venti giovani cittadini che sfilavano, disposti in due file appaiate, per le vie di Pisa. Essi indossavano «abiti ricchissimi e di forma assai bizzarra», mentre i cavalli erano «coperti tutti di panno scarlatto con le armi della Comunità». I primi due giovani portavano la bandiera del Comune e quella del Popolo, i successivi due i vessilli imperiali, mentre la terza coppia due aquile vive simboli della Repubblica. Il corteo era poi chiuso da un seguito di trombettieri e pifferai. La futura Piazza dei Cavalieri era in quel giorno di bando coronata di bandiere. Come riporta Tronci (da cui tuttavia si distanzia Vigo), su tutte le torri della città (che egli quantifica in ben sedicimila) venivano posti i vessilli del Comune, del capitano del Popolo e l’aquila imperiale. Tale pratica risulta anche per le sedi delle magistrature cittadine: quindi per il Palazzo degli Anziani.
Dai documenti è possibile dedurre che, durante la vigilia della festa, la piazza fosse il punto di partenza di un ricco corteo che avrebbe portato gli Anziani e il capitano del Popolo alla cattedrale primaziale di Santa Maria Assunta per le celebrazioni del vespro. «In gran pompa e maestà», gli Anziani erano preceduti da «donzelli vestiti di nuova livrea e così i trombetti accompagnati dal capitano colle sue masnade e da tutti gli altri inferiori magistrati».
Altro aspetto centrale della cerimonia era l’offerta (in realtà obbligatoria e dovuta da tutti i cittadini, nonché dai borghi e villaggi del territorio pisano) di ceri da depositare presso il Duomo la sera della vigilia. Come ricorda Vigo «tre giorni prima dell’Assunzione, il podestà faceva prescrivere a ciascuno, sotto pena da darsi a suo arbitrio, di andare a presentare al Duomo il proprio candelo, affinché tutte quante le offerte fossero quivi recate nell’ordine consueto». Persino la foggia dei ceri cui dovevano provvedere le più alte magistrature era accuratamente prescritta dalle ordinanze pubbliche. Dai documenti emergono dettagli vividi: i “candeli” si trasformavano in complesse elaborazioni artistiche grazie al lavoro di artigiani specializzati. Istoriati, dipinti, spesso decorati con l’applicazione di vessilli e frange. Quello degli Anziani – con ogni probabilità il più ricco – era ornato, ad esempio, da «fimbria e pennones» (frange e stendardi). Il cerimoniale di presentazione dei candeli al Duomo prevedeva un corteo complesso: sebbene manchino riferimenti specifici, è legittimo ipotizzare che la processione di offerta del cero degli Anziani partisse proprio dalla Piazza delle Sette Vie: posto su una «trabacca» (per Vigo si tratta di un padiglione probabilmente collocato su di un carro per preservare il candelo dagli agenti atmosferici), veniva accompagnato da ventisei uomini pagati per l’occasione dal Comune e da suonatori di tromba.
L’area urbana poi trasformata in età medicea costituiva dunque anche nelle celebrazioni dell’Assunzione uno dei fulcri della vita sociale della città di Pisa ai tempi della Repubblica: in essa avevano luogo tutte le cerimonie più rilevanti per l’ethos comunale, in grado di accrescere la concordia tra i poteri e l’unità dell’ordine civile e religioso. Questi documenti e queste celebrazioni ci permettono per altro di immaginare una piazza in continua evoluzione e sempre diversa a seconda degli impieghi: le decorazioni, i simboli, i palchi mobili, le processioni, financo la stessa folla andavano a comporre uno scenario di volta in volta cangiante, presentando uno spazio fisicamente identico ma sempre diverso.
1312
Enrico VII e la Turris leonis
Nell’occasione della visita a Pisa, nel 1312, all’imperatore Enrico VII venne regalato un leone probabilmente dal Comune, che nei decenni successivi risultò impegnato nelle spese per il mantenimento di un leone presente in città (forse non la medesima fiera offerta in dono). Questo impegno da parte delle magistrature cittadine ha suggerito di riconoscere il luogo di cattività dell’animale presso la futura Piazza dei Cavalieri, dove era attestata negli stessi anni una Torre del leone (Turris leonis).
Nella delicata situazione in cui Pisa si venne a trovare nel passaggio fra Due e Trecento – onerata dalle pesanti condizioni di pace imposte all’indomani della sconfitta della Meloria contro Genova (1284), stretta per terra dalle mire delle guelfe Firenze e Lucca e insidiata nei domini di mare dal papato che, in accordo con la corona aragonese, voleva sottrarre alla città il dominio sulla Sardegna –, le speranze del Comune si concentrarono su Enrico VII. Questi, eletto imperatore nel 1308, aveva subito espresso il proposito di guidare una campagna in Italia e, nella primavera 1310, aveva inviato ambasciatori a Pisa, come ad altre città, per sondare il terreno prima della propria calata. È in questo clima che i pisani, nel marzo 1310, si affidarono a Federico da Montefeltro, fra i più eminenti ghibellini italiani, a cui conferirono gli straordinari poteri delle cariche congiunte di podestà e capitano generale del Comune. Così facendo, rinnovellavano un rapporto con i Montefeltro già provato col padre di Federico, Guido, che aveva posto fine alla diarchia del conte Ugolino e di Nino Visconti.
Nello stesso 1310, appena ebbe varcato le Alpi, si fecero incontro all’imperatore Giovanni Zeno Lanfranchi e il giurisperito Giovanni Bonconti, per offrirgli l’incondizionato appoggio pisano, e, in novembre, altri cittadini pisani raggiunsero la corte ad Asti, dove giurarono fra i consiglieri del re.
Le speranze riposte da Pisa nella venuta di Enrico si manifestarono apertamente in occasione dell’arrivo in città, il 6 marzo 1312. L’imperatore giunse per mare, da Genova, e dopo lo sbarco fece una prima tappa in San Pietro a Grado, importante meta di pellegrinaggio; di lì raggiunse la città, dove fu accolto presso le mura dalla cittadinanza, che gli fece dono di un baldacchino purpureo tempestato di oro e gemme, descritto dal cronachista Ferreto Vicentino, e di una preziosa spada. Ad attendere l’«Alto Arrigo», come ebbe a dire Dante (Paradiso, XXX, 137), oltre alla cittadinanza pisana c’era il fior fiore dei fuoriusciti guelfi di Toscana, compreso probabilmente il famoso poeta, nonché il piccolo Petrarca, con il padre.
La prima sede a ospitare Enrico fu il palazzo arcivescovile, presso la chiesa primaziale pisana, che gli fu aperto dal vicario arcivescovile Enrico da Montarso. Il 17 marzo, infatti, furono stilati gli atti con cui l’imperatore prendeva il pieno dominio sulla città (che comportava la nomina diretta degli Anziani, nonché il ricevimento del giuramento di fedeltà da parte dei magistrati del Comune e dell’intera cittadinanza) e le cerimonie si svolsero davanti all’ecclesia maior della Beata Vergine Maria. Pochi giorni dopo, tuttavia, egli si trasferì con la corte a sud, nel quartiere di Chinzica, presso l’elegante palazzo dei fratelli Gherardo e Bonaccorso Gualandi.
Nelle pur ricche notizie che si addensano attorno ai due soggiorni dell’imperatore nella città, non si incontrano fatti o eventi degni di nota che abbiano come teatro l’odierna Piazza dei Cavalieri, che sicuramente, come centro nevralgico della vita politica pisana, vide svolgere, all’ombra dei suoi palazzi, celebrazioni e cerimonie pubbliche. È tuttavia importante da rilevare un particolare messo recentemente in luce dagli studi storici, ovvero la comparsa, fra le note di spesa della corte durante il soggiorno pisano, di pagamenti per il mantenimento di un leone, scalati il 28 marzo e il 15 aprile (prima della partenza da Pisa il 23 del mese). È possibile che la fiera fosse giunta in dono all’imperatore dal Comune pisano come regalo diplomatico, con un palese valore simbolico della dignità regale, ed è significativo che l’unico altro leone vivo tenuto in città nel Trecento e registrato dalle fonti fosse un animale di proprietà del Comune attestato nel 1317 e nel 1337. Due provvigioni risalenti a quegli anni, infatti, riguardano il mantenimento di un leone e la seconda (18 luglio 1337), in particolare, menziona un «nuntius camerae pisani Communis» (‘un messo della camera del Comune di Pisa’), che «dedit et dare debet pastum leoni pisani Communis» (‘diede e deve dare il pasto al leone del Comune pisano’). Pio Pecchiai, che aveva rinvenuto questi documenti a inizio Novecento, collegò la memoria del leone a una «Turris leonis» attestata nel 1330 presso la Piazza degli Anziani, poi Piazza dei Cavalieri, e, anche se il toponimo potrebbe rispecchiare piuttosto un’insegna araldica che lo connotava, il riferimento resta plausibile. Nasce, perciò, la suggestiva ipotesi che durante il soggiorno imperiale a Pisa un leone, offerto in dono a Enrico VII, fosse mantenuto presso la piazza centrale del potere civico, al pari di altri animali simbolici che erano allevati negli edifici della piazza, come le aquile nella Torre della Fame. Per qualche tempo, in seguito, l’appellativo di Torre del leone sarebbe rimasto nella toponomastica, anche se, ci dicono i registri delle spese della corte, il leone donato a Enrico lo seguì fino a Roma, dove se ne perdono le tracce nella contabilità regia.
1355
Condanne ed esecuzioni pubbliche
Nell’inoltrato maggio 1355, mentre Carlo IV di Lussemburgo si trovava a Pisa, la Piazza del Popolo divenne teatro di un occasionale e spietato episodio legato alla rinnovata conduzione politica della città: la condanna capitale e l’esecuzione pubblica di coloro che erano stati giudicati avversari o addirittura traditori dell’autorità imperiale.
Il giuramento di fedeltà che gli organi istituzionali del Comune pisano avevano prestato a Carlo IV, re dei Romani e imminente imperatore, una volta entrato trionfalmente in città nel gennaio 1355, ebbe come conseguenza diretta che costui figurasse come tutore della pace e della giustizia civiche. Non stupisce perciò constatare che tra i primi atti emanati dal sovrano ci sia stato un bando che prevedeva che ogni cittadino presentasse istanza a lui in persona circa eventuali ingiurie ricevute. Tali poteri aumentarono nei mesi successivi, quando grazie ai Raspanti (fazione cittadina da subito alleatasi con Carlo e i suoi) gli venne riconosciuto da un consiglio appositamente convocato il titolo di signore di Pisa e di Lucca. Tutti questi passaggi si seguono bene nell’opera del principale cronista locale dei fatti relativi al soggiorno di Carlo, ovvero Ranieri Sardo. Al suo ritorno insieme alla moglie Anna di Świdnica dall’incoronazione a Roma nel mese di maggio, la città si trovava in pieno subbuglio a causa del presunto scorporo di Lucca dalla dominazione pisana. È in quel contesto di disordini che si verificò un episodio eclatante.
Il 26 maggio, in seguito all’emanazione di una condanna capitale gravante su di loro, tre membri della potente famiglia Gambacorta – Francesco, Lotto e Bartolomeo, figli di Bonaccorso, dipinti come veri e propri nemici dell’Impero – e altri quattro imputati – Neri Papa, Ugo Guitti, Giovanni delle Brache e Cecco Cinquina –, tutti e sette accusati di tradimento e di tentata uccisione di Carlo IV, vennero esemplarmente giustiziati nella Piazza del Popolo (in seguito Piazza dei Cavalieri), proprio di fronte al Palazzo degli Anziani (futuro Palazzo della Carovana). Si conosce da tempo il documento che reca la sentenza promulgata dal tribunale del capitano del Popolo Mellino da Tolentino. Ma sono le fonti storiche a narrarci con dovizia di dettagli l’accaduto. Dalla consueta Cronaca di Pisa di Sardo apprendiamo che i condannati vennero condotti da Via Santa Maria ai piedi della scalinata d’accesso al palazzo comunale e, letto il giudizio, furono decollati davanti al popolo pisano lì riversatosi. A ciò si aggiunge che per la città fu diffuso il mandato che nessuno osasse avvicinarsi ai cadaveri, che inizialmente sarebbero dovuti rimanere esposti nella piazza per tre giorni, fino al 29 maggio, prima di essere deposti: la preziosa testimonianza diretta costituita dal Liber de Coronatione Karoli IV Imperatoris di Giovanni Porta da Annoniaco ci informa che il boia era stato incaricato di giustiziarli al più presto, per evitare che qualcuno dei Bergolini (altra fazione pisana) tentasse di liberarli. In verità, pare che i corpi siano restati in mostra per un’ora soltanto, e che subito dopo Carlo abbia concesso ai cittadini la grazia di seppellirli.
Matteo Villani, nella sua Cronica, ha raccontato i fatti in modo molto simile, incrementandoli di alcuni particolari: costoro «furono menati in camicia cinti di strambe [corde molto robuste composte di fibre vegetali] e di cinghie, e a modo di vilissimi ladroni tirati e tratti da’ ragazzi, furono così vilmente condotti dal Duomo di Pisa alla Piazza degli Anziani». La vicenda, infine, è ripercorribile anche attraverso la lettura della Cronica di Pisa (manoscritto Roncioni 338 dell’Archivio di Stato di Pisa), dove l’autore ignoto ha fornito una versione più sintetica rispetto alle precedenti e ha collocato i fatti al 28 maggio anziché al 26 – così come avrebbe fatto secoli dopo Jacopo Arrosti nel primo libro delle Croniche di Pisa (1654). Resta comunque fermo il dato che per la ricca storiografia pisana del XIV secolo si sia trattato di un evento tanto straordinario da divenire topico e irrinunciabile per narrare la conduzione della ‘signoria’ imperiale sul Comune alla metà del Trecento.
È di nuovo Ranieri Sardo a rammentarci che, nell’agosto 1397 (stile pisano), fu ancora un Gambacorta, Carlo di Gherardo, canonico della Cattedrale, a ricevere la pronuncia della propria condanna a morte nella piazza civica della città. In questo caso, l’accusa che gravava su di lui non era più di aver leso la maestà imperiale, bensì di aver tentato in varie occasioni, in accordo con i fiorentini, d’impossessarsi di alcuni castelli nel contado pisano, come ha registrato anche il compositore fiorentino della Cronica volgare, già attribuita a Piero di Giovanni Minerbetti. Tuttavia, la decollazione non avvenne in loco, ma al «mercato delle bestie» la mattina del 12 agosto, cinque giorni dopo la cattura e la detenzione presso la Cittadella.
In conclusione, alla luce di quanto si coglie dalle testimonianze, sembra che, mentre la pubblica lettura delle sentenze capitali ai piedi della scalinata d’accesso al Palazzo degli Anziani si sia verificata più volte (Sardo, ad esempio, ne menziona anche una di natura soltanto pecuniaria, annunciata però allo stesso modo nel gennaio 1398), quella delle cruenti esecuzioni in Piazza del Popolo non fosse affatto una pratica usuale e che il caso dei tre Gambacorta con gli altri quattro del Popolo, nella primavera inoltrata del 1355, sia stato del tutto eccezionale, dettato da peculiari contingenze politiche interne conseguenti alla presenza fisica dell’imperatore in città.
1361
Festa del Corpo di Cristo
Attestata dal 1361, la festa del Corpo di Cristo era celebrata a Pisa da un corteo che partiva dalla Cattedrale e qui si concludeva, dopo aver sfilato per varie strade ed essere passato per la futura Piazza dei Cavalieri, cuore politico della città. Questo nesso simbolico tra Piazza del Duomo e Piazza dei Cavalieri restituiva alla comunità medievale l’immagine potente dell’unitarietà e della concordia tra i poteri del Comune.
Nel Medioevo, le feste religiose – a Pisa come in molti comuni italiani – costituivano un momento centrale per la vita della comunità. La loro importanza è spesso desumibile dalla cura con cui le ordinanze pubbliche, stratificate in decenni di attività legiferativa, disciplinavano persino i dettagli più minuti di un cerimoniale articolato e rigoroso. I documenti relativi alle delibere degli organi civili e religiosi, in particolare per quanto attiene al XIII e XIV secolo (conservati presso l’Archivio di Stato di Pisa) registrano la marcata volontà di formalizzare un rituale decisivo per la vita del comune: dalla foggia e quantità delle offerte, ai costumi delle autorità, alla struttura dei cortei e al loro tragitto. In particolare, il percorso che si snodava tra le vie e le piazze cittadine era pensato per abbracciare simbolicamente a un tempo i luoghi del potere politico e quelli del potere religioso, restituendo una concordia ordinum che era anche alla base della religione civile del comune. La Piazza degli Anziani o del Popolo, futura Piazza dei Cavalieri, diviene all’interno di tale cornice uno snodo obbligato per tutte le cerimonie cittadine.
Come riporta l’anonima trecentesca Cronica di Pisa, la prima celebrazione della festa del Corpo di Cristo ha luogo il 27 maggio 1361. La stessa fonte ne attribuisce l’istituzione all’«Operaio di Santa Maria Maggiore, il quale avea nome Ser Bonagiunta Masca». Otto giorni prima, banditori ingaggiati dagli Anziani «a suon di trombe» chiamavano a raccolta le masse cittadine: «ogni persona, maschi e femmine, debbiano andare la mattina della festa del Corpo di Cristo a Duomo, alla Chiesa maggiore, e alla processione accompagnare lo Corpo di Cristo». Tutti i partecipanti erano tenuti a portare un cero, la cui dimensione era rigorosamente stabilita in base al rango del soggetto: i privati cittadini erano soliti portare ceri da mezza libbra o da una libbra («secondo la sua possibilitade»), mentre gli Anziani da due. La processione prendeva avvio dalla cattedrale primaziale di Santa Maria Assunta, proseguiva per Via Santa Maria, deviando poi (con ogni probabilità) per l’attuale Via dei Mille. Da qui imboccava la piazza, pagando così tributo al cuore politico della città, prima di proseguire in un percorso che l’avrebbe riportata in Duomo: «E si partì di Duomo per Via Santa Maria, ed alla Piazza delli Anziani, e per Borgo, e per di Lungarno dalla Piazza delli pesci, e del Ponte nuovo [struttura distrutta nel corso del XIV, che collegava Via Santa Maria a Via Sant’Antonio]; e per Via Santa Maria tornonno a Duomo». La connessione diretta tra Piazza del Duomo e Piazza dei Cavalieri restituiva l’immagine potente dell’unitarietà e della concordia tra i poteri del Comune.
Secondo la descrizione del testimone, il cuore del corteo era costituito dall’ostia (per i cattolici simbolo del Corpo di Cristo) custodita in un tabernacolo d’oro portato dall’arcivescovo. Il capo del potere religioso comunale era accompagnato dai canonici del Duomo che tenevano «un palio di seta drappo fine», mentre a seguire vi erano le massime cariche laiche: Anziani, podestà, capitano del Popolo, nonché il vicario dell’imperatore. A chiudere il corteo «uomini e donne grandi e piccoli della Città». Dal racconto si deduce che tale cerimonia era preceduta («Levato lo Sole a due ore»: circa alle otto di mattina) da una processione di «Frati e di Preti e di tutte le Compagnie de’ Battuti della Città di Pisa, e poi l’Arcivescovo di Pisa». I Battuti erano membri di confraternite laiche cittadine use alla penitenza della flagellazione: «E tutti questi Battuti andavano battendosi col sacco in dosso, ciascuno col suo Gonfalone». Sebbene sia ammissibile ipotizzare che anche quest’ultimo corteo seguisse l’itinerario del maggiore e sfilasse quindi per la Piazza del Popolo, il cronista non è chiaro sul punto

1382-1383
Processioni per scongiurare la peste
Per scongiurare il perdurare della peste tra il 1382 e il 1383, le magistrature cittadine si fecero carico dei permessi e delle spese per traslare le reliquie di san Guglielmo di Malavalle da Castiglion della Pescaia a Pisa; qui, dopo la solenne benedizione nella Cattedrale, vennero conservate nel Palazzo degli Anziani (poi Palazzo della Carovana) e furono oggetto di devozione da parte della cittadinanza.
L’endemia della peste nera in Italia a partire dal 1348, e il suo periodico riaffacciarsi in forme disastrose, è una costante che tocca tutte le realtà cittadine della Penisola. Non fa eccezione Pisa, che, dopo il 1348, subì violente ondate nel 1362, nel 1372, nel 1382-1383 e nel 1391. Fra queste, la pestilenza perdurata dall’estate del 1382 all’autunno del 1383 può essere presa come osservatorio privilegiato per indagare come la città reagisse al dilagare del morbo e a quali forme di spiritualità ricorresse, giacché essa è stata descritta con dovizia di particolari nell’anonima Cronaca (detta Roncioni), risalente alla fine del XIV secolo.
Il momento storico è quello della signoria di Pietro Gambacorti (1369-1392), il quale, nella parabola declinante delle istituzioni comunali a Pisa, aveva assunto le cariche di capitano di guerra e difensore del popolo, divenendo di fatto la principale autorità cittadina, nonostante la sopravvivenza degli organi di governo repubblicani.
A fronte dell’inanità dei pochi provvedimenti di ordine sanitario per porre un freno al contagio, sembra che il Comune reagisse in pieno accordo con le autorità ecclesiastiche nel promuovere quelle forme di spiritualità che più sembravano opportune per impetrare l’aiuto divino e la liberazione dal morbo. L’anonimo cronachista elenca le molteplici processioni succedutesi a partire dall’ottobre del 1383, con il concorso del popolo, del clero, ma anche delle magistrature cittadine, con il collegio degli Anziani, il podestà e il capitano del Popolo. Come è stato giustamente osservato da Cecilia Iannella, l’iter processionale probabilmente ricalcava quello tramandato dall’anonimo nel descrivere la prima processione del Corpus Domini, che si tenne a Pisa nel giugno del 1361. Essa principiò presso la cattedrale per poi proseguire su Via di Santa Maria e quindi giungere alla «piassa delli Ansiani», vale a dire nell’area urbana poi indicata come Piazza dei Cavalieri, quindi lungo il Borgo e percorrendo il Lungarno verso ovest fino al ponte, dove la processione imboccava di nuovo Via di Santa Maria per tornare al Duomo.


D’altra parte, le istituzioni comunali non si limitarono all’intervento nelle processioni religiose. L’anonimo, con altre fonti posteriori, addita chiaramente che fu il Comune a chiedere il permesso papale per traslare le reliquie di san Guglielmo di Malavalle da Castiglion della Pescaia a Pisa e ad animare una serie di manifestazioni religiose tese a propiziarsi l’assistenza del santo, considerato un protettore contro la peste. Le reliquie entrarono in città da Porta San Marco il 4 agosto 1383 e furono accolte dagli Anziani, nonché dal clero cittadino, dal popolo e dalle compagnie di battuti, fra le quali di certo ebbe la preminenza la compagnia di san Guglielmo, nata probabilmente un decennio prima, in occasione della peste del 1372, e committente, attorno al 1383, della bella insegna processionale di Antonio Veneziano, oggi conservata al Museo Nazionale di San Matteo. Al termine della processione, le reliquie furono portate in Duomo per una messa solenne, minuziosamente descritta dal cronachista; tuttavia, dopo la celebrazione, la cassa contenente le spoglie fu traslata nel Palazzo degli Anziani (poi Palazzo della Carovana), dove rimase, sorvegliata giorno e notte e chiusa da due chiavi, una delle quali deteneva il priore degli Anziani, l’altra l’abate dell’eremo di San Guglielmo a Castiglione. In quell’agosto, le processioni si ripeterono dal 10 al 13 e il 18 del mese, seguendo lo stesso itinerario, che terminava immancabilmente in Duomo, con la messa solenne, l’ostensione delle reliquie e, ricorda il cronachista, molte guarigioni miracolose ed esorcismi. Tuttavia, la stessa fonte precisa che tra il 16 e il 18 d’agosto le reliquie furono esposte mattina e sera alla devozione popolare presso il Palazzo degli Anziani, «in della chiostra giuso che vvi si fecie uno altare, e quine si mostravano le ditte erelique». Si trattava, dunque, di un luogo di culto approntato per l’occasione, in uno spazio semipubblico, dove i cittadini accorrevano, chi a donare una somma, chi a offrire candele, chi a baciare il feretro per ottenere la sperata guarigione. Le reliquie tornarono a Castiglione il 26 d’agosto; tuttavia, a Pisa il culto del santo eremita permase a lungo, come attestano le fonti iconografiche, nonché la sopravvivenza, fino al Settecento, della confraternita a lui dedicata.
Un’altra occasione in cui le istituzioni comunali ebbero a mostrare il loro protagonismo nel momento della peste furono le esequie del podestà Jacopo da Bologna, morto durante l’ondata del 1382. Le celebrazioni, spesate dal Comune, contemplarono la processione – e si vede bene che questa era la manifestazione più ricorrente del legame fra la cittadinanza e le sue istituzioni – dal Palazzo del Podestà, dove era stata esposta la salma, fino alla sepoltura in San Francesco.
Media gallery
1406
L’ultima celebrazione del Gioco del Mazza-scudo
Almeno dal pieno XII secolo nella futura Piazza dei Cavalieri, e occasionalmente in altri contesti urbani, si svolse un evento ciclico carnevalesco a tema bellicoso che coinvolgeva la componente maschile della cittadinanza: il Gioco del Mazza-scudo. La festa, che già in antico è stata ritenuta una sorta di precedente del Gioco del Ponte (manifestazione medicea inaugurata nel 1568), fu abolita all’inizio della dominazione fiorentina nel 1406.
Una targa commemorativa, affissa nel 1985 sulla parete esterna dell’oratorio di San Rocco, rammenta ai passanti che nell’area urbana indicata dal toponimo ‘delle Sette Vie’, poi Piazza dei Cavalieri, in età medievale aveva abitualmente luogo il Gioco cosiddetto del Mazza-scudo, pratica diffusa in numerosi Comuni italiani. Essa è stata interpretata dagli studiosi di storia locale come la più probabile origine premoderna della successiva tradizione goliardica pisana del Gioco del Ponte, storica competizione tra le due parti di Mezzogiorno e di Tramontana (in ciascuna delle quali sono raggruppate sei magistrature o quartieri cittadini), tutt’oggi rievocata con orgoglio sul Ponte di Mezzo a cadenza annuale, nel mese di giugno.
Sebbene non ne forniscano alcuna descrizione particolareggiata, due fonti moderne di natura cronistico-erudita, le Istorie pisane di Raffaello Roncioni (concluse nel 1605 circa) e le Croniche di Pisa di Jacopo Arrosti (1654), attestano che l’usanza vigeva stabilmente in città almeno dal pieno XII secolo. La prima occorrenza nel testo di Roncioni, infatti, permette di collocarla nell’inverno 1168 (stile pisano), per quanto quell’anno avesse avuto luogo non nella piazza, ma sull’Arno ghiacciato. Entrambe le opere però la presentano come un costume ben più antico, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. La notizia aggiunta da Arrosti, ovvero che all’insediamento dei fiorentini seguirono l’interruzione del gioco e l’obbligata consegna ai nuovi governatori da parte dei pisani delle mazze lignee adoperate, si trovava già esposta in una Cronichetta quattrocentesca incentrata sull’assedio della città, edita nel secondo Ottocento insieme ad altre sempre anonime. Dopo l’inaugurazione del Gioco del Ponte nel 1568, alcune opere letterarie presentarono il Mazza-scudo come la mediazione tra le usanze locali di presunta fondazione romana e la neo-insediata cultura medicea cosimiana: è il caso, ad esempio, della Descrizione delle pompe e feste fatte ne la città di Pisa di Giovanni Cervoni (1588-1589). Per conoscere il carattere e l’organizzazione dell’evento, invece, possiamo contare su alcune testimonianze letterarie precedenti, tutte elaborate, però, dopo che la competizione aveva già cessato di esistere.
Il Lamento di Pisa di Puccino d’Antonio di Puccino da Pisa (primo terzo del Quattrocento, oltre 300 versi) e il Lamento di Pisa di Giovanni di Iacopo di Talano da Pisa (1452, 117 stanze) segnalano in forma generica che il gioco si svolgeva nella «piazza», sottintendendo con ogni probabilità la futura Piazza dei Cavalieri. Ben più ricco d’informazioni è invece un poemetto anonimo in volgare dal titolo Il Giocho del massa-schudo che si data ai primi decenni del XV secolo, edito per la prima volta in un opuscolo di nozze del 1882 per opera del dottor Stefano Monini, priore dei Bagni di San Giuliano e possessore del manoscritto (che si ritiene perduto), e a cura della Tipografia di Tito Nistri. Articolato in quarantaquattro stanze di otto versi ognuna, il componimento conferma anzitutto l’indicazione dell’ultimo anno in cui la festa avrebbe avuto luogo in città, ovvero il 1406. Descrive quindi come venisse predisposta la piazza, almeno negli ultimi tempi, al fine di ospitarla: lo spazio centrale tra gli edifici era delimitato da un anello di catene dotato di due aperture affrontate, in modo tale da far entrare all’interno i partecipanti. Le due fazioni principali di cavalieri (l’una del Gallo e l’altra della Gazza, riconoscibili per i colori dei rispettivi elmi, per la prima gialli e per la seconda rossi), proprio come nel successivo Gioco del Ponte, erano a loro volta suddivise in compagnie o magistrature contraddistinte da stendardi e uniformi. Una volta conclusi la parata iniziale lungo le vie che conducevano alla piazza e il posizionamento dei contendenti, il torneo consisteva dapprima in duelli tra uomini armati di una mazza e di uno scudo, in sfida per la conquista della donna amata (presente come spettattrice in mezzo al pubblico); in un secondo momento, s’instaurava a suon di tromba lo scontro corale tra i due gruppi di contendenti. È ancora il componimento a raccontarci che il periodo in cui si celebrava l’evento era compreso tra il Natale e il Carnevale di ogni anno. Mentre gli edifici affacciati sulla piazza avevano i balconi e le finestre addobbati con sfarzo e pronti ad accogliere gli osservatori, «nel palagio maggior», ovvero nel Palazzo degli Anziani, prendevano posto «i signuori cho’ cittadini de la terra i maggiori».
Che gli esponenti politici del Comune presenziassero dall’interno del Palazzo degli Anziani conferiva certamente alla festa una forte connotazione pubblica, poi approdata a una dimensione granducale con il Gioco del Ponte vero e proprio, benché, com’è stato sottolineato dalla critica più recente, sia impossibile provare una dipendenza diretta dello spettacolo mediceo-lorenese da quello medievale. Ciò che la pur esigua memoria storica del Mazza-scudo ci trasmette è che questa manifestazione, assorbita nei suoi contenuti ideologici dalle istituzioni comunali pisane tanto da essere celebrata stabilmente in loro stretta prossimità topografica, non ebbe ragione di esistere in seguito alla perdita dell’autonomia cittadina a inizio Quattrocento.

1406
Il discorso di Gino Capponi, dopo la conquista di Pisa
Il 9 ottobre 1406 Gino Capponi riuscì a valicare con le sue truppe le mura cittadine in modo pacifico, senza bisogno di attivare un’incursione armata, e prese subito il comando di Pisa. Si avviava così il rapido processo di definitiva conquista del Comune da parte di Firenze, con l'instaurazione di un governo che da quel momento sarebbe durato ininterrottamente per circa un secolo, fino al 1494, due anni dopo la morte di Lorenzo il Magnifico.
Un riquadro affrescato nel 1585 da Bernardo Barbatelli, meglio noto come Bernardino Poccetti, sulla volta della Sala Grande di Palazzo Capponi a Firenze rappresenta la scena del discorso pubblico tenuto da Gino di Neri Capponi nell’estate 1406 di fronte alla popolazione e alle principali istituzioni pisane riunite nella Piazza del Popolo (poi Piazza dei Cavalieri), dall’alto della scalinata esterna d’accesso al Palazzo degli Anziani, poi Palazzo della Carovana. Non esistono ad oggi conferme documentarie note circa quanto specificamente illustrato nell’opera del pittore fiorentino, licenziata quasi due secoli dopo l’accaduto. Tuttavia, tale testimonianza visiva si lega strettamente alle vicende storiche che si verificarono nei primi anni del XV secolo e che portarono la Firenze pre-medicea a estendere il proprio dominio politico e miliare su Pisa.
Gino Capponi (Firenze, 1350 circa-1421), protagonista dell’operazione e primo governatore di Pisa, fu un importante uomo politico fiorentino. Discendente di una famiglia di mercanti, iniziò ad ottenere incarichi pubblici più o meno di rilievo dalla fine del XIV secolo, dopo essersi legato in maniera esplicita agli Albizzi. Nella primavera 1405, quando per Firenze si rese finalmente concreta la possibilità di acquisire Pisa nella sua rete territoriale estera, Capponi faceva parte della magistratura dei Dieci della Guerra. Con questo ruolo, fu inviato presso Genova, Livorno e Pietrasanta per condurre trattative dapprima con Jean Le Maingre Boucicault, governatore della repubblica ligure da quattro anni, e in un secondo momento con Gabriele Maria Visconti che, dopo la morte del padre Gian Galeazzo nel 1402, risultava ufficialmente signore di Pisa. Quando, a cinque mesi dall’avvio delle pratiche, il negoziato sembrava andato a buon fine senza necessità di ricorrere allo scontro armato, la situazione si complicò: l’occupazione della Fortezza pisana il 31 agosto 1405 provocò un’inattesa insurrezione dei cittadini, per far rientrare la quale fu Capponi a dover gestire l’esercito fiorentino, allestito allo scopo di assediare la città attorno alle mura. Ciò che avvenne nell’anno successivo ci è tramandato da varie fonti quattrocentesche prodotte sia dal versante dei conquistatori sia da quello dei vinti, alcune delle quali sono utili per ricostruire almeno in parte quanto accaduto proprio nella Piazza del Popolo all’indomani della penetrazione in città e dell’immediata resa pisana.
Tra quelle prodotte in ambito fiorentino, la prima che interessa in questa sede consiste nei sei Capitoli dell’acquisto che fe’ il Comune di Firenze, di Pisa, poemetto in terza rima dantesca redatto da Giovanni di Ser Piero, podestà di Castel Fiorentino, nel 1408. Qui si può scorrere la narrazione ritmata del graduale accerchiamento di Pisa da parte delle truppe comandate da Capponi, azione che prese piede all’incirca dalla metà di maggio 1406 e che si concluse con l’accordo sottoscritto congiuntamente a Giovanni Gambacorta, il quale durante la vacanza di potere aveva assunto il controllo della città, ottenendo in cambio il governo su Bagno di Romagna. La sera di sabato 9 ottobre, giorno dei santi Dionigi di Francia e Donnino, i fiorentini fecero il loro ingresso valicando le mura da Porta San Marco senza scorrerie armate o saccheggi, trovandosi al cospetto di una popolazione affamata a causa dei lunghi mesi di assedio esterno e della conseguente impossibilità di procacciarsi risorse. Come recitano i versi di Giovanni di Ser Piero, uno dei primi atti compiuti da Gino Capponi e dai suoi, una volta dentro, fu l’aver «preso del palagio signoria», ovvero essersi impadroniti del Palazzo degli Anziani, simbolo per eccellenza dell’ormai decaduto potere civico comunale. Qualche decennio più tardi fu con ogni probabilità il primogenito del governatore, Neri, a scrivere i Commentari di Gino di Neri Capponi dell’acquisto, ovvero presa di Pisa seguita l’anno MCCCCVI, un testo in prosa basato forse su appunti e ricordi del padre, tradotto poi in latino da Bernardo Rucellai alla fine dello stesso secolo. Dalla loro lettura si apprende che, giunte le truppe nella piazza, subito venne creato cavaliere il giovane fiorentino Jacopo Gianfigliazzi e fu mandato il cancelliere Scolaio d’Andrea di Guccio al cospetto di chi stava ancora nel Palazzo degli Anziani, affinché si trovasse al più presto per il capitano e i commissari una consona sistemazione. A quel punto, prese inizio la parata lungo le principali vie del centro.
Possiamo poi contare su un’anonima Cronica volgare già attribuita a Piero di Giovanni Minerbetti, che ricopre un arco temporale dal 1385 al 1409 e che procede con andamento annalistico; sul Diario fiorentino di Bartolomeo di Michele del Corazza, stilato per sequenze di brevi appunti tra il 1405 e il 1439; e sui Ricordi di Giovanni di Pagolo Morelli, compilati fino al luglio 1421. In questi tre casi i dati veicolati, sebbene corrispondano, risultano più scarni che nei testi precedenti e, soprattutto nel Diario, l’attenzione è massimamente concentrata sul clima di festa che si respirava per le strade di Firenze dopo la ricezione della notizia della vittoria. Da ultimo, è importante fare menzione del trattato De captivitate Pisarum dell’umanista fiorentino Matteo Palmieri. Costui, nato proprio in quel 1406, non fu dunque un testimone contemporaneo ai fatti, ma si occupò di rielaborare alcune fonti a sua disposizione (in special modo i Commentari del figlio di Gino, Neri, al quale è appunto dedicata l’opera). È interessante cogliere che nel testo di Palmieri i fatti del 9 ottobre si svolsero davanti al futuro Palazzo della Carovana, indicato già come «Priorum palatium» e non più come residenza degli Anziani, con un riferimento, dunque, alla magistratura che occupava l’edificio sotto il dominio fiorentino, nel momento in cui l’autore scriveva (1445). Da lui apprendiamo anche che già in quel giorno vennero apposte sulla facciata del palazzo «Florentini populi signa».
Spostando invece lo sguardo sul versante pisano, ci imbattiamo in una Cronichetta d’autore ignoto e in dei Ricordi altrettanto anonimi, opere ambedue copiate da Giuseppe Odoardo Corazzini in un volumetto del 1885 che raccoglie alcune fonti sino ad allora inedite sull’assedio di Pisa. Se la prima non rappresenta nulla di eccezionale rispetto alle attestazioni di parte fiorentina elencate poc’anzi, la seconda costituisce l’unica altra testimonianza nota oltre ai Commentari, tra quelle coeve all’accaduto, che reca il testo dell’orazione pronunciata da Gino nella Piazza del Popolo. Nel trattato del Palmieri compare un lungo discorso che si presenta come il rifacimento umanistico di quanto si legge nell’opera di Neri. Lo stesso Jacopo Arrosti, nel secondo libro delle sue erudite Croniche di Pisa (1654), si è limitato a riportare i soli avvicendamenti nella Piazza e nel Palazzo del 9 ottobre, giorno dell’assedio. È solo il giorno successivo all’invasione, infatti, che Capponi prese pubblicamente parola, rivolgendosi agli Anziani in procinto di lasciare la loro residenza e ai cittadini pisani. Le due orazioni tràdite dai Commentari e dai Ricordi differiscono in maniera estesa nella forma, ma serbano il medesimo tono trionfale e al contempo accomodante nei confronti del popolo appena privato dell’autonomia di cui aveva gloriosamente goduto per secoli.
Media gallery
1565
Cerimonia di fondazione della chiesa di Santo Stefano
Come da tradizione invalsa all’avvio di importanti costruzioni, la posa della prima pietra della chiesa conventuale di Santo Stefano dei Cavalieri fu accompagnata da una cerimonia ufficiale, che vide coinvolto il duca Cosimo de’ Medici, il cardinale e arcivescovo metropolitano di Pisa Angelo Niccolini, il clero locale e un folto gruppo di cavalieri in abito istituzionale. Nelle fondamenta dell’edificio furono gettate alcune medaglie, coniate in diversi metalli e recanti impresso il volto di Cosimo.
Il programma unitario concepito da Giorgio Vasari per Piazza dei Cavalieri incluse, dopo la costruzione del Palazzo della Carovana, l’erezione di una chiesa, necessaria e imprescindibile per un ordine guerresco fondato sulla difesa del Cristianesimo. Intitolato a Santo Stefano papa e martire, eponimo dell’Ordine, l’edificio sorse in parte sul sito dell’antica chiesetta di San Sebastiano alle Fabbriche maggiori e in parte su lotti di terreno privato, allineandosi perfettamente al profilo della facciata del contiguo palazzo vasariano. La demolizione delle guaste mura di San Sebastiano e lo scavo delle nuove fondamenta richiesero circa un triennio, nel corso del quale i membri dell’Ordine, approvato da Pio IV nel 1562, officiarono provvisoriamente nella vicina chiesa di San Sisto, fino a quando, nell’aprile 1565, non si avviarono i lavori per la fabbrica del nuovo edificio conventuale.
Gli studi sono stati finora non unanimi nel circoscrivere le esatte date di riferimento a cui ancorare i primi sviluppi della costruzione della chiesa e questo anche a causa del variare, tra fonti e documenti, di anni in stile pisano (con anticipo di nove mesi dal 25 dicembre) e in stile fiorentino (con ritardo di due mesi e venticinque giorni rispetto al calendario odierno). Giovanni Capovilla, che per primo ha reso note e commentato le carte d’archivio relative al cantiere, fissò l’avvio dei lavori al 12 aprile 1565, giorno in cui risulta registrata l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell’Ordine. Nelle fondamenta dell’edificio furono però gettate lastre marmoree, scolpite da Stoldo Lorenzi su ordine dell’architetto Davide Fortini, recanti la data del 6 aprile 1565, che porterebbe dunque verosimilmente ad anticipare di qualche giorno il reale momento d’inizio. Esse racchiudevano la seguente iscrizione:
Cosmus Medices Florentiē et Senarum Dux Inclytus | Fundata hac pietiss. A Nobilium equitum universitate | ad Reip. Christiane decus et incrementum, voluit eam esse | in fide et tutela Divi Stephani Pape et Martyris | Fanum hoc Divo eidem extruendum dedicandumque curavit | Lapidem primum, privumque, primus ipse iecit | Angelus Nicolinus Pontifex Pisanus et Cardinalis verba de more preivit | Actum anno a Servatoris ortu MDLXV | VI | Aprilis | Kyrianus Stroza Philosophie et Humanarum literarum professor, eiusdemque | Ducis in re literaria Administer Pisis
[Cosimo de’ Medici, illustre duca di Firenze e di Siena, fondata questo pietosissimo collegio di nobili cavalieri a gloria e incremento della repubblica cristiana, volle che fosse nella fede e sotto la protezione di santo Stefano papa e martire. Fece costruire e dedicare questo tempio allo stesso santo. La prima pietra fu posta, per primo, dallo stesso duca, con il rito avviato dal cardinale Angelo Niccolini, ‘pontefice di Pisa’, che pronunciò le parole secondo l’usanza. Fatto nell’anno 1566 dalla nascita del Salvatore, il 6 aprile. Ciriaco Strozzi, professore di Filosofia e Lettere umanistiche e ministro dello stesso duca per le cose letterarie a Pisa.]
Il seppellimento nelle fondamenta dei nuovi edifici di lastre e medaglie che commemorassero l’evento, lasciandone traccia indelebile per i posteri, rispondeva a un’usanza assai consueta, adottata presso le corti italiane (e non solo) fin dal Quattrocento, e particolarmente cara al casato mediceo, come testimoniano – per citare due soli esempi tra i molti possibili – analoghe cerimonie, con gettata di medaglie di Cosimo e Francesco de’ Medici nelle fondamenta, celebrate per le costruzioni delle fortezze «della Stella e del Falcone in Portoferraio» all’Isola d’Elba e di Terra del Sole a Castrocaro Terme (1565). Quanto invece alla posa della prima pietra, nel 1815 Giovanni Domenico Anguillesi collegava erroneamente questo avvenimento alla nomina di Cosimo a gran maestro dell’Ordine, il 15 marzo 1562 (1561 in stile fiorentino), mentre è oggi chiaro che l’evento dovette svolgersi nello stesso aprile del 1565. Capovilla ritenne di poter individuare il giorno esatto nel 17 del mese, data desunta da una nota di spese che si presume tuttavia redatta a posteriori, mentre l’attendibile resoconto seicentesco di Giuseppe Setaioli descrive la solenne processione svoltasi l’8 aprile 1565 (1566 in stile pisano) «a hore 11 incirca […] con l’assistenza del cardinale Niccolini arcivescovo e due vescovi, li canonici e tutto il clero et li regolari e circa cento cavalieri vestiti d’abito con le solite cerimonie».
La prima lastra della chiesa conventuale, posata «sotto il canto avanti la chiesa verso il palazzo» dal duca Cosimo, giunto appositamente a Pisa per l’occasione, recava impressa un’arme di casa Medici sormontata dalla croce stefaniana «con alcune lettere latine et attorno sui canti vi era alcuni incavi tondi […] dove il duca, fatta la cerimonia, pose più medaglie d’oro, d’argento, di metallo con la sua impronta e sopra quattro piastre di rame che coprivano dette medaglie e sopra un’altra pietra simile alla prima incastrata con metalli». Non è chiaro quali fossero le medaglie cosimiane utilizzate per Santo Stefano. Cinquanta esemplari in bronzo, citati senza ulteriori specifiche nella Guardaroba Medicea, vennero inviati nel 1565 a Pisa per questo scopo. Stando a una ricostruzione già proposta in bibliografia, questi sarebbero da identificare in pezzi recanti al diritto l’effigie del duca e al rovescio la fabbrica degli Uffizi, già coniati in precedenza da Domenico Poggini. Non si può però escludere che si tratti verosimilmente di medaglie realizzate dallo stesso artista secondo un nuovo, apposito tipo. Sono infatti ancora oggi conservati al Museo Nazionale del Bargello due esemplari bronzei (invv. 6407; Dep. 2990) che non solo presentano al recto l’immagine di Cosimo, ma soprattutto recano al verso l’iscrizione «RELIGIONIS ERGO», accompagnata dal giglio fiorentino, che sembrano attagliarsi perfettamente all’occasione.
1585
L’ambasciata Tenshō a Pisa
Nella primavera del 1585, Francesco I de’ Medici ricevette a Pisa la visita di quattro giovani ambasciatori giapponesi, partiti da Nagasaki alla volta dell’Europa. L’occasione permise dal granduca di esibire la ricchezza dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano e la magnificenza delle sue sedi: gli ospiti furono condotti in visita sia nel Palazzo della Carovana, sia nella chiesa di Santo Stefano, dove poterono presenziare a una cerimonia sacra.
A dare impulso alla spedizione era stato il gesuita Alessandro Valignano (1539-1606), Visitatore delle Indie, ansioso di esibire il felice esito dell’evangelizzazione e conversione alla religione cristiana condotte in Asia dalla Compagnia di Gesù. Valignano aveva a questo scopo selezionato quattro giovani rampolli di nobili famiglie giapponesi convertitesi al cristianesimo – Itō Sukemasu, battezzato Mancio, e Chijiwa Seizaemon, battezzato Michele, a rappresentanza dei signori feudali del Giappone; poi i nobili Nakaura Jingorō e Hara Nakatsukasa, che presero i nomi rispettivamente di Giuliano e di Martino –, affinché raggiungessero la Santa Sede e omaggiassero papa Gregorio XIII. La spedizione assunse a posteriori il nome di ‘Ambasciata Tenshō’ («Tenshō shōnen shisetsu», ossia «missione dei ragazzi nell’era Tensho»), e fu di fatto la prima ambasciata giapponese a raggiungere l’Europa.
L’eccezionale portata dell’evento è documentata da svariati libelli e cronache a stampa coeve, come le Relazioni della venuta degli ambasciatori giapponesi a Roma sino alla partita di Lisbona (1586) di Guido Gualtieri. Straordinario valore documentario ha poi il De missione Legatorum Iaponensium ad Romanam Curiam (1590), un dialogo ‘odeporico’ che intercorre tra i quattro giovani protagonisti, verosimilmente scritto in spagnolo da Valignano stesso e tradotto in latino dal gesuita portoghese Duarte de Sande. Dalla lettura di queste e altre fonti, sappiamo che dopo aver attraversato l’Oceano Indiano e aver affrontato una lunga circumnavigazione dell’Africa, i viaggiatori approdarono a Lisbona, fecero tappa a Madrid, alla corte di Filippo II, e, spostatisi ad Alicante, raggiunsero per via di mare la costa tirrenica della penisola italiana, sbarcando a Livorno; dopo aver visitato alcune città dello stato granducale, procedettero sino a Roma, dove Gregorio XIII accordò loro un’udienza privata il 23 marzo 1585. Nonostante il loro itinerario fosse stato accuratamente scandito da Valignano, furono numerose le deviazioni cui i principi nipponici dovettero acconsentire: una di queste lunghe digressioni avvenne alla corte medicea di Pisa, dove l’ambasceria sostò per cinque giorni, dal 2 al 7 marzo 1585.
Francesco I de’ Medici, che dimorava allora in questa città insieme alla granduchessa Bianca Cappello, ebbe così il privilegio di accogliere nel proprio stato, primo tra i governanti italiani, i viaggiatori. Approdati a Livorno il 1° marzo del 1585, i giovani giapponesi furono ricevuti da un suo emissario che li invitò a raggiungere il giorno dopo lo sbarco, su carrozze granducali, Pisa, dove «trovarono un palazzo per loro riccamente apparecchiato». Così decorosamente ricevuti da Francesco I, dai suoi fratelli Pietro e Ferdinando e dalla granduchessa, i missionari furono invitati a soggiornare nell’antica dimora pisana della famiglia, sita in prossimità della chiesa di San Matteo (oggi sede della Prefettura).
Una cinquecentina stampata a Firenze nel 1585 racconta che in quell’occasione Mancio, per compiacere le curiosità ‘etnologiche’ del granduca, si presentò al suo cospetto vestito degli abiti tradizionali giapponesi, sfoggiando «un paro di scarpe dilicatissime di corame di color mascherezato, con calzetti agucchiati di varii colori, […] un paro di calzoni pendenti in foggia turchesca fino sul collo del piede, tessuti di drappo d’oro, e di ricamo, con smeraldi, perle e rubini, […] una casacca lunga senza maniche, fino alla cintura ricamata di simili gioie, con superbissimi e ricchissimi lavori». Così mirabilmente abbigliato, il nobile Mancio – continua l’anonimo cronachista – sarebbe stato ritratto «in pittura dal Buontalenti». Di quest’ultimo aneddoto non si trova conferma né nella cronaca di Gualtieri, né nel De missione, dove si accenna soltanto alla viva ammirazione che le vesti tradizionali esibite dai giovani destarono nei granduchi.
L’agenda dei legati giapponesi, arrivati a Pisa tra la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima, si snodò tra eventi mondani e cerimonie sacre, oltre a visite ad alcuni monumenti cittadini. La sera stessa del loro arrivo, il gruppo si intrattenne a Palazzo Medici, dove la granduchessa Bianca stava ospitando un sontuoso ballo di corte; qui, come racconta un vivace brano del De missione, i giovani forestieri suscitarono l’ilarità generale dei nobili astanti, dimostrando la loro imperizia nelle danze europee.
Il giorno successivo, stando ancora alla stessa fonte, si dedicarono alla visita del «templum maximum miris sumptibus aedificatum» («il tempio maggiore [il Duomo di Pisa] costruito con grandi ricchezze»), e poi del «conventum eorum, qui Divi Stephani equites appellantur», ossia del «convento di quelli che sono chiamati Cavalieri di Santo Stefano», con ogni probabilità il Palazzo della Carovana. Dopo una breve digressione sui prestigiosi ordini cavallereschi fondati da principi e re di tutta Europa, Michele – colui che nella finzione dialogica del De missione sta descrivendo i giorni pisani – passa a raccontare la visita alle sedi dell’Ordine di Santo Stefano – la chiesa omonima e il palazzo conventuale – e a enumerare le grandi ricchezze dell’istituto cavalleresco. In questo contesto, il singolare status di Francesco I de’ Medici, accresciuto dal patrocinio di un ordine religioso-militare, dovette stupire i quattro viaggiatori, ai cui occhi il granduca risultò a tutti gli effetti pari a un re.
All’interno della chiesa di Santo Stefano, i quattro viaggiatori ebbero l’occasione di assistere e partecipare alla liturgia del Mercoledì delle Ceneri: il primo giorno di Quaresima del 1585, alla presenza di ottanta cavalieri stefaniani e, naturalmente, del loro gran maestro (lo stesso granduca), anche i giovani giapponesi ricevettero l’imposizione delle ceneri sulla fronte. Francesco I sedette su un alto seggio collocato in prossimità dell’altare maggiore, e di fronte a lui, in posizione altrettanto preminente, vennero accolti i quattro ospiti. Prima che il rito avesse inizio, i cavalieri, nei loro abiti cerimoniali, si inchinarono al cospetto dei forestieri, per poi genuflettersi dinnanzi all’altare e dignitosamente riverire il granduca con il baciamano. Al termine della messa, i viaggiatori poterono ammirare i moltissimi stendardi espugnati dalle galee stefaniane alle navi piratesche ed esibiti sulle pareti della chiesa a memoria delle vittorie conseguite dall’Ordine che – stando alla nostra fonte – poteva allora contare quattro navi, rapide e ben equipaggiate.
Nonostante nel 1585 fosse ancora priva della sua facciata, la chiesa di Santo Stefano non mancò di destare la viva ammirazione del gruppo: il narratore definisce la sua struttura architettonica «notevole come quella della sede dell’ordine», vale a dire il vicino Palazzo della Carovana. Questo edificio costituì l’ultima tappa del ‘tour’ pisano offerto da Francesco I ai giovani principi nipponici, che furono poco dopo invitati a proseguire verso Firenze. All’interno del palazzo, a ulteriore conferma delle trionfali imprese condotte dai Cavalieri di Santo Stefano, il gruppo di ambasciatori poté contemplare le «molte sacre reliquie, un ricchissimo tesoro, un armadio pieno di ogni specie di armi».

1588
Ingresso di Ferdinando I a Pisa
Il 31 marzo 1588 la città di Pisa in festa celebrò la solenne entrata del nuovo granduca Ferdinando I de’ Medici, acclamato da folle festanti e accolto dagli esponenti di maggior spicco del panorama locale. Dopo aver attraversato le vie del centro, decorate da apparati effimeri e costellate di monumentali archi trionfali, Ferdinando e il suo seguito si ritirarono in Palazzo Medici sul Lungarno, recandosi il giorno successivo a far visita ai cavalieri di Santo Stefano. Questi accolsero e omaggiarono il granduca – e loro gran maestro – con una ossequiosa cerimonia nella chiesa conventuale, giurandogli incondizionata obbedienza.
Partito da Firenze con qualche giorno di anticipo e fermatosi poi presso la Villa dell’Ambrogiana, la mattina del 31 marzo 1588 il cardinale, e da pochi mesi nuovo granduca di Toscana, Ferdinando I de’ Medici raggiunse Pisa, dove fece, come da tradizione, il suo trionfale ingresso per «venire a rivedere e a dar’ ordine di riformare la sua nobile città». In vista del prestigioso arrivo la comunità locale, pur non versando all’epoca in condizioni di prosperità economica, si era mobilitata per addobbare ogni angolo della città e per allestire sontuosi apparati festivi nei punti nevralgici del centro, che sarebbero stati toccati dalla processione di accompagnamento del granduca. Preziosa e dettagliata testimonianza dell’evento si trae dalla descrizione scritta dal letterato e giureconsulto mediceo Giovanni Cervoni, che diede conto con dovizia di particolari sia della preparazione e degli sviluppi della cerimonia che dell’aspetto di singole installazioni ed elementi decorativi.
Dopo essere stato accolto a Cascina dalle milizie pisane e da alti dignitari cittadini, Ferdinando smontò dalla sua carrozza, salì in sella a una chinéa (cavallo bianco da parata) e scortato da una foltissima comitiva si rimise in cammino alla volta della città. Il transito si avviò da Porta San Marco, davanti alla quale fu eretto un monumentale arco trionfale dedicato alla celebrazione del buon governo granducale; proseguì quindi, tra stuoli di folla acclamante, lungo la Via di San Martino fino alla chiesa del Santo Sepolcro, dove era stato collocato un secondo arco, finanziato dalla Nazione fiorentina e allusivo alle virtù morali del sovrano, a cui facevano seguito gli apparati approntati dall’Ufficio dei fiumi e fossi, inneggianti all’efficacia delle disposte bonifiche territoriali, e dalla Dogana. Attraversato il «Ponte vecchio» (attuale Ponte di Mezzo), nuovi archi attendevano Ferdinando: uno all’altezza dell’attuale Piazza Garibaldi, ornato da tele aventi per soggetto episodi della sua vita e della sua carriera, e uno più avanti sul Lungarno, in direzione del «nuovo palazzo» di sua altezza (attuale Palazzo Reale), voluto dallo Studio pisano, che ne celebrava la statura intellettuale. Il corteo avanzò infine «sotto l’arco e palco ordinato per la Musica […], la qual si fece nel suo passare», e quello dell’arsenale navale, su cui si stagliavano le statue allegoriche di Giustizia e Pace.
Trascorsa la notte nel palazzo di famiglia, il giorno successivo il granduca volle rendere omaggio con una visita ai cavalieri dell’Ordine stefaniano, di cui egli era gran maestro, che lo accolsero a loro volta con solenni celebrazioni in una Piazza dei Cavalieri vestita a festa. Coordinatori e responsabili dei lavori per la messa in opera degli allestimenti festivi furono Ottavio Piazza e Ridolfo Sirigatti. Scortato al di sotto di un baldacchino, Ferdinando fu condotto all’ingresso della chiesa di Santo Stefano, la cui facciata, allora incompleta e dunque non dotata del rivestimento marmoreo che vi si vede ancora oggi, era stata per l’occasione coperta da impalcature lignee atte a sostenere le strutture effimere utilizzate per renderne più maestoso l’aspetto. Un grande portale architravato era stato infatti anteposto a quello reale di accesso all’edificio, affiancato da pilastri scanalati sormontati da festoni e iscrizioni e intervallati tra loro da tele dipinte con personificazioni della Beatitudine, della Vittoria, della Vita attiva e contemplativa, della Fedeltà e dell’Ubbidienza, unite alle insegne araldiche del granduca. L’interno della chiesa, anch’esso spoglio e privo di decorazioni come la facciata, era stato interamente rivestito da festoni, paramenti di stoffa lavorata, bandiere e da un ciclo di cinque tele a monocromo (tuttora in situ) con Episodi della vita di santo Stefano I papa e martire, secondo un programma iconografico ancora una volta ideato da Sirigatti ed eseguito da un gruppo di pittori più e meno noti, tra cui Alessandro Pieroni dell’Impruneta, Giovanni Stradano e Giovanni Balducci detto il Cosci. Ferdinando fu ricevuto dal Priore dell’Ordine, che gli diede l’acquasanta e lo trasse poi all’altare maggiore, dove i cavalieri, tutti raccolti e riuniti in chiesa per l’occasione, gli resero omaggio offrendogli la propria obbedienza, mentre i musici intonavano in sottofondo il Te Deum.
Media gallery

1609
Il granduca Cosimo II accoglie i vincitori della battaglia di Bona
Affacciata sulla costa algerina, la città di Bona (oggi Annaba) rappresentava un baluardo strategico per la compagine turca, macchiatasi poco tempo prima della missione stefaniana di terribili torture inflitte ai soldati cristiani catturati a seguito di un naufragio. Il 16 settembre 1607, non senza difficoltà, l’esercito mediceo riuscì a espugnare la roccaforte nemica e nell’aprile del 1609 la vittoria, tra le più importanti mai raggiunte dall’Ordine, venne infine celebrata a Pisa, con una solenne cerimonia allestita in Piazza dei Cavalieri che vide protagonista il giovane granduca Cosimo II, da poco succeduto al padre Ferdinando I.
La presa della città di Bona, corrispondente all’attuale Annaba, sulla costa nord-orientale dell’Algeria, fu l’esito di un’importante operazione militare condotta via mare e via terra dai cavalieri di Santo Stefano al servizio del granduca di Toscana Ferdinando I de’ Medici. Comandanti della missione furono l’ammiraglio Iacopo Inghirami e il gran contestabile dell’Ordine stefaniano Silvio Piccolomini, aio (cioè precettore) del giovane gran principe Cosimo II, in nome del quale fu armata la spedizione. Il movente del piano fu probabilmente l’attacco di pirateria perpetrato poco tempo prima ai danni di alcune navi dell’Ordine, naufragate proprio al largo della costa magrebina, i cui soldati furono tratti prigionieri e sottoposti a orrende torture che culminarono nell’ostensione delle loro teste mozzate sulla sommità delle mura di Bona. Al di là delle ragioni legate alla volontà di vendicare i propri caduti, la città costituiva una delle più insidiose roccaforti ottomane dell’area mediterranea e la sua definitiva espugnazione avrebbe quindi portato grande vantaggio, in termini di immagine e di affermazione di potere, al governo ferdinandiano, ancor più dopo la disfatta di Famagosta, sull’isola di Cipro, assediata dai Turchi nell’estate del 1607.

223 x 301 mm

La flotta stefaniana era composta da nove galee, tre galeoni e due bertoni (navi a tre alberi), con un seguito di imbarcazioni minori e un’armata di oltre duemila uomini, tra cavalieri e soldati di ventura. La missione fu studiata e programmata nei minimi dettagli, ma alcuni imprevisti nelle fasi di avvicinamento alla costa ne causarono un pericoloso ritardo, tale da metterne a repentaglio l’intero esito. Ciò nonostante, il 16 settembre 1607, Piccolomini decise di procedere allo sbarco e pur nella difficoltà dell’impresa, riuscì a guidare le sue truppe verso la vittoria. Conclusa la battaglia, Bona venne saccheggiata e data alle fiamme, mentre l’esercito si accinse immediatamente a ripartire alla volta di Livorno.
Le vittorie sui Turchi, paradigmi della Ecclesia triumphans, furono sempre oggetto di sontuose celebrazioni da parte dell’Ordine, che si atteneva per questi eventi a un ben preciso e codificato cerimoniale. L’impresa di Bona fu dunque festeggiata a Pisa il 1° aprile 1609, con una processione in Piazza dei Cavalieri e una messa solenne nella chiesa di Santo Stefano. Dalle cronache e dai documenti dell’epoca sappiamo che per l’occasione il granduca Cosimo II, da poco succeduto al defunto padre, e sua moglie Maria Maddalena d’Austria avevano raggiunto la città con qualche giorno di anticipo, il 26 marzo; vestiti gli abiti di gran maestro dell’Ordine, il 1° aprile successivo, Cosimo accolse in chiesa il corteo processionale aperto dai Cavalieri del Tau (già antico Ordine di San Giacomo d’Altopascio, assorbito alla fine del Cinquecento dall’Ordine stefaniano) e dai suonatori di trombe, seguiti dal gran contestabile Piccolomini con lo stendardo della Religione, da tredici prigionieri con le insegne, in vesti da parata, e dagli altri cavalieri. Inginocchiato davanti all’altare, il granduca si raccolse in preghiera, dopodiché le bandiere turche predate a Bona vennero offerte al monsignore officiante, che le benedisse sancendone la definitiva consegna all’Ordine. La meticolosa programmazione dell’evento, di cui si conserva memoria scritta presso l’Archivio di Stato di Pisa, aggiungeva che a conclusione delle celebrazioni «Sua Altezza Serenissima si ritirerà in sagrestia a spogliarsi l’abito, et nel istesso tempo tutti i signori cavalieri si caveranno l’abito. Sua Altezza Serenissima poi tornerà a sentir messa piana».
Nel 1613 i Cavalieri fecero dedicare una delle tavole dipinte sul soffitto della chiesa di Santo Stefano alla battaglia di Bona, tema già toccato anche da Bernardino Poccetti e aiuti in un ciclo di pitture al piano nobile di Palazzo Pitti a Firenze (1607-1609). Le celebrazioni del 1609 sono invece raffigurate in un più tardo affresco eseguito da Baldassarre Franceschini detto il Volterrano nel loggiato esterno della Villa Medicea della Petraia, nei pressi di Firenze (1636-1646), nell’ambito di un più ampio intervento decorativo atto a commemorare i trionfi medicei. Il successo delle flotte stefaniane fu infine oggetto, nel 1694, di un poemetto eroico-encomiastico dedicato a Cosimo III de’ Medici dal conte e cavaliere dell’Ordine Vincenzo Piazza, intitolato Bona espugnata.

Media gallery

1683
Traslazione delle reliquie di santo Stefano
Il 25 aprile 1683 ebbe luogo a Pisa la solenne cerimonia di traslazione delle reliquie di santo Stefano papa e martire dalla chiesa di San Benedetto a quella dei Cavalieri. L’evento si svolse sotto la regia del guardarobiere granducale Diacinto Maria Marmi, che ne ideò i sontuosi apparati effimeri, e vide la partecipazione in Piazza dei Cavalieri di molti membri della famiglia Medici. La cerimonia culminò in Santo Stefano, dove per l’occasione Giovan Battista Foggini aveva approntato il gigantesco modello in legno e stucco raffigurante il Santo tra la Religione e la Fede, ancora oggi conservato nell’edificio sacro.
L’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano desiderava possedere le spoglie del santo fin dal 1571, quando a Giorgio Vasari venne chiesto di adoperarsi in tal senso; all’epoca però le reliquie, anteriormente conservate in diversi luoghi di Roma, risultavano disperse. Nel 1611 vennero rinvenuti piccoli frammenti del corpo e alcune ampolle del sangue del santo nel monastero dei minori osservanti di Santa Maria della Colonna a Trani, che il granduca Ferdinando II de’ Medici cercò invano di ottenere.
Solo nel 1682, sotto il regno di Cosimo III de’ Medici, dopo lunghe trattative con le autorità civili e religiose di Trani, di cui il santo era ormai divenuto protettore, e a seguito di un breve di papa Innocenzo XI, le reliquie vennero concesse all’Ordine. Dopo il loro arrivo – via terra fino a Napoli e poi via mare – le sacre spoglie furono inizialmente conservate nella chiesa inferiore di San Benedetto, soggetta alla giurisdizione dei Cavalieri, i quali organizzarono la cerimonia di traslazione per la domenica in albis dell’anno successivo, il 25 aprile 1683, in concomitanza con la riunione del Capitolo Generale dell’Ordine, nel corso del quale si sarebbero rinnovate le cariche per tre anni.
Lo svolgimento della cerimonia, culminante in Piazza dei Cavalieri, e i ricchi parati che adornavano il percorso tra le due chiese sono descritti da alcune fonti – manoscritte e a stampa –, e da una lettera di Diacinto (o Giacinto) Maria Marmi, all’epoca guardarobiere granducale, che ideò gli apparati effimeri per l’evento. Concorrono a ricostruire la fastosa cerimonia i pagamenti ai numerosi artisti e artigiani conservati all’Archivio di Stato di Pisa, un nutrito gruppo di disegni – divisi tra Firenze, Pisa e New York – e un’incisione raffigurante proprio gli apparati della piazza. Il nucleo grafico era in parte funzionale a produrre una relazione a stampa dotata di illustrazioni, a oggi non rintracciata e forse mai pubblicata. La relazione doveva essere corredata di nove vedute della festa, commissionate a Domenico Tempesti e Bastiano Tromba. Nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi sono stati rintracciati sei disegni di Marmi, interpretati come schizzi eseguiti a cerimonia conclusa e poi forniti ai due artisti. I tre disegni presso l’Archivio di Stato di Pisa sembrano appartenere a una fase precedente, più operativa, risalente all’elaborazione dell’allestimento vero e proprio e, a mio giudizio, senza che sia certa l’attribuzione a Marmi. Nonostante l’effettiva esecuzione dei disegni da tradurre a stampa da parte di Tempesti e Tromba – testimoniata da un pagamento di 40 scudi –, una sola delle nove vedute, quella dell’interno di Santo Stefano, è stata rintracciata in The Morgan Library and Museum di New York.
Nel corso della festa, attentamente ricostruita da Barbara Riederer-Grohs e soprattutto da Franco Paliaga, l’urna con le reliquie venne prelevata dalla chiesa inferiore di San Benedetto ed esposta tra ceri e argenterie nell’altare di quella superiore, parata per l’occasione con arazzi rappresentanti storie sacre. La facciata di San Benedetto era ornata da un’impalcatura con pilastri, ricoperti di cotonina a scacchi bianca e turchina, che sorreggevano un fregio e un cornicione arricchiti da bandiere. Tra le allegorie della Pietà e della Giustizia era posto un arazzo raffigurante le gesta di Cosimo I de’ Medici (non facilmente riconoscibile nel disegno degli Uffizi).
L’urna venne posta sotto un baldacchino e portata in processione dal granduca Cosimo III in abito da gran maestro e da un seguito di quattrocento persone tra cavalieri e clero. Il corteo procedette sul Lungarno fino al Ponte di Mezzo, che costituiva un altro punto clou del percorso, segnalato al passaggio dal fuoco di mortaretti, oltre che dal ricchissimo parato: introdotto e concluso da due archi trionfali, prevedeva una copertura con tende ‘da galera’, fregi e altri panni colorati. Arazzi con le figure della Fede, della Speranza, dell’Allegrezza e del Dolore erano stati posti all’inizio e alla fine del ponte. Anche negli spazi tra i pilastri furono inseriti arazzi con figure allegoriche.
Lungo la Via del Borgo erano affissi una serie di arazzi con Storie dei Medici (Cosimo il Vecchio, Lorenzo il Magnifico, Clemente VII, Cosimo I), il cosiddetto parato ‘della Vigilanza’, il ciclo delle ‘feste fiorentine’, e altre serie dedicate a personaggi mitologici.
Un altro arco trionfale, su cui era stato apposto un episodio a chiaroscuro della Vita di santo Stefano, introduceva nella piazza, interamente circondata da un loggiato ligneo ad archi che sosteneva diverse serie di arazzi: tra queste le Storie di san Giuseppe e di Fetonte, il parato ‘degli Elementi’, le Nozze tra Enrico IV e Maria de’ Medici e singoli pezzi raffiguranti storie sacre. In piazza, ad attendere la processione, erano diversi esponenti della famiglia Medici: la granduchessa Vittoria della Rovere, i principi Ferdinando e Gian Gastone e il cardinale Francesco Maria, fratello del granduca.
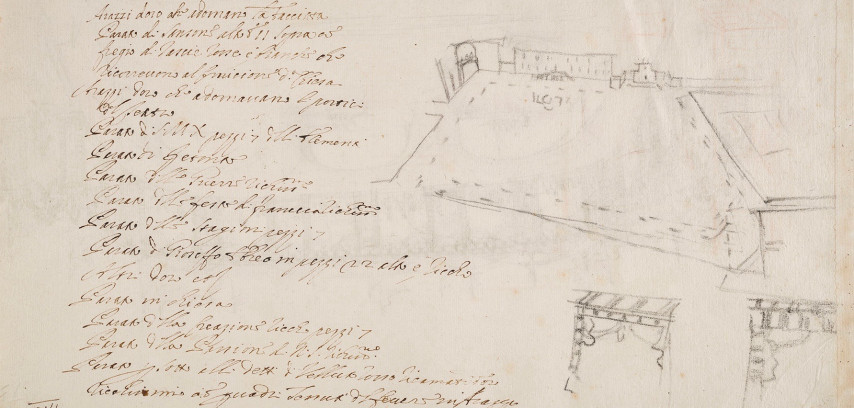

Sciolto il corteo, si procedette a entrare in chiesa. Davanti ad essa erano state sistemate due colonne, sovrastate dalla figura della Religione recante lo stendardo con l’arme dei Cavalieri e ai piedi le spoglie nemiche, e da quella della Vittoria, anch’essa con spoglie nemiche ai piedi, mentre nelle mani teneva lo stendardo e una corona. Sui piedistalli delle colonne erano incatenate quattro figure di prigionieri. Sulla facciata della chiesa campeggiava il ritratto del granduca Cosimo III, eseguito da Pietro Dandini coadiuvato da doratori e tessitori.
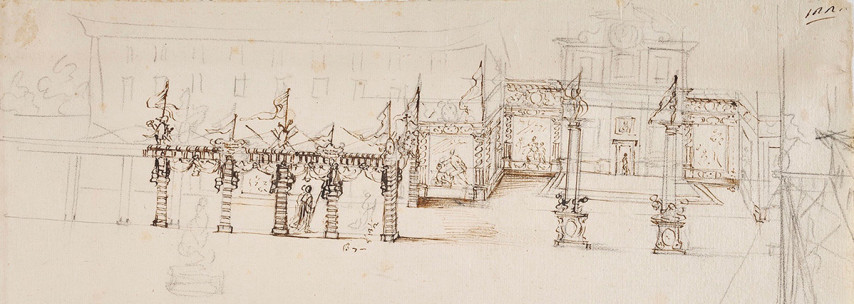
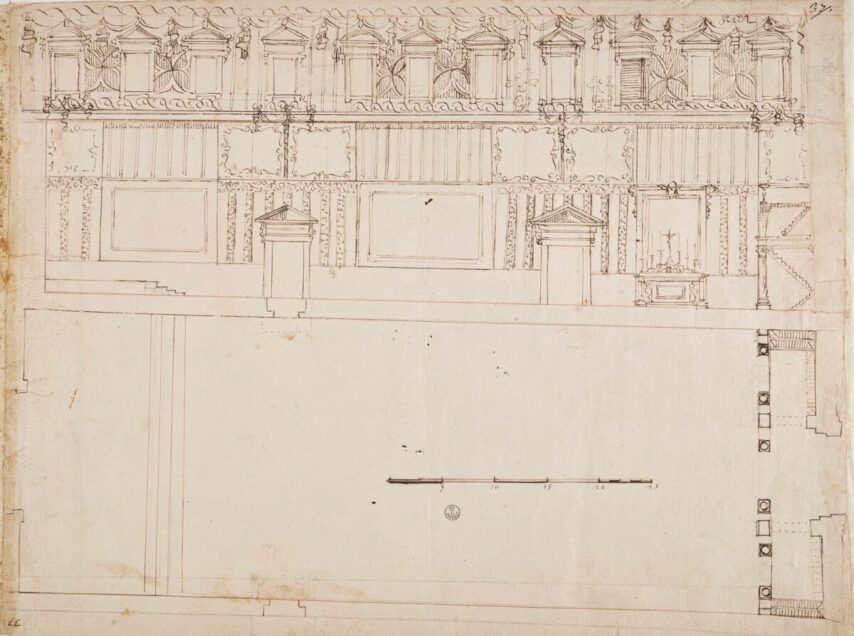


L’interno della chiesa era stato dotato di un palco per i musici, di troni per il granduca e il priore Felice Marchetti, e di ‘gabinetti’ per ospitare gli invitati e la corte: tra questi, oltre alle autorità dell’Ordine, erano presenti l’arcivescovo di Pisa Francesco Pannocchieschi d’Elci, e il vicegerente della diocesi di Roma monsignor Giacomo De Angelis. La chiesa era parata con diverse serie di arazzi: delle Grottesche, di Sansone, della Creazione di Adamo. Dal soffitto, invece, pendeva uno stendardo raffigurante il santo con un angelo e, ai piedi, la figura della Religione genuflessa. Sull’altare maggiore, progettato per l’occasione da Pier Francesco Silvani, campeggiavano le figure in gesso e legno realizzate da Giovan Battista Foggini, raffiguranti il Santo tra la Religione e la Fede, oggi conservate in un ambiente a destra del presbiterio.
L’evento fu senza precedenti. Diacinto Maria Marmi soggiornò a Pisa per 43 giorni e curò, coadiuvato da un vero e proprio team, ogni singolo aspetto, compresi i lunghi lavori di adeguamento del sito: dalla sistemazione degli interni della chiesa (comprensiva di dorature, spolverature, movimentazione dei materiali), a quella degli assi viari interessati dal passaggio del corteo. Furono effettuati lavori di miglioria sulle facciate e sui tetti degli edifici. Le strade vennero ricoperte di rena e la piazza ripulita e lastricata in alcuni punti con acciottolato.
Franco Paliaga sottolinea la particolarità della cerimonia, svoltasi da un luogo di pertinenza dell’Ordine a un altro – marcati rispettivamente dai ritratti di Cosimo I e Cosimo III –, che attraversava gli assi più importanti della città (Lungarni e Borgo) tramite un sistema di gallerie coperte.
Gli apparati effimeri concepiti da Marmi corrisposero tanto ad esigenze economiche quanto simboliche: molti arazzi provenivano dalla Guardaroba medicea; tende e altri tessuti da Santa Maria Novella e da numerose istituzioni fiorentine, pisane e livornesi; altri oggetti da prestiti privati. Il vasto repertorio sacro e profano suscitò meraviglia e ammirazione, puntando principalmente sull’aspetto decorativo, anche se alcuni arazzi palesavano ovviamente il nesso tra la dinastia medicea e l’Ordine, esaltando la necessità della lotta contro l’invasore in un momento storico particolare: l’avanzata turca alle porte di Vienna.
Media gallery
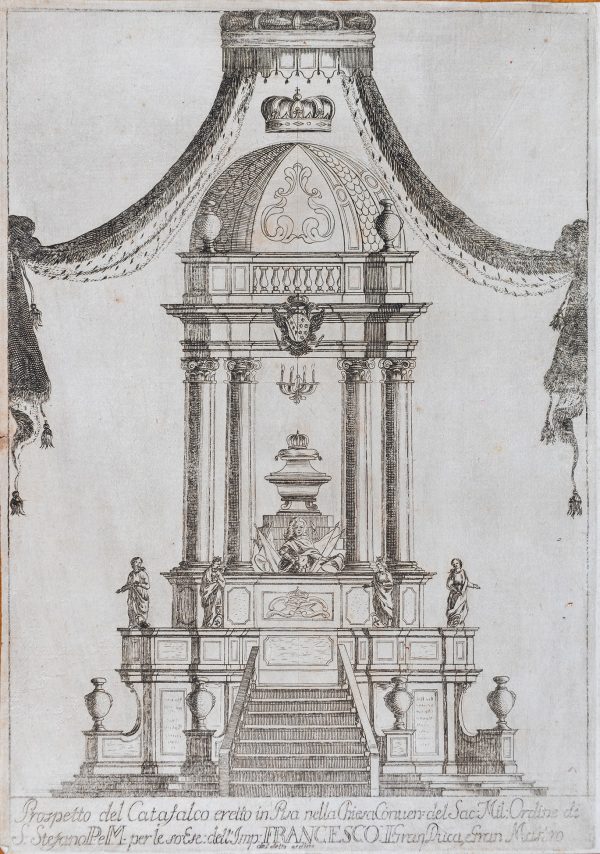
1765
Pompe funebri per la morte di Francesco I di Lorena
A partire dal 19 dicembre 1765 si avviarono a Pisa le sontuose celebrazioni funebri in memoria dell’imperatore Francesco I di Lorena, scomparso improvvisamente nell’estate di quell’anno lasciando come eredi i figli Giuseppe e Pietro Leopoldo. L’evento fu organizzato dall’Ordine di Santo Stefano (di cui il Lorena era gran maestro in veste di granduca di Toscana), che per l’occasione curò con meticolosa attenzione tutti i dettagli della cerimonia e dell’allestimento interno ed esterno della chiesa conventuale.
Morto improvvisamente a Innsbruck la sera del 18 agosto 1765, stroncato da un ictus mentre si trovava in carrozza con il figlio Giuseppe, Francesco Stefano di Lorena (1708-1765), imperatore del Sacro Romano Impero con il nome di Francesco I di Lorena dal 1745 e granduca di Toscana con il nome di Francesco III dal 1737, lasciò i suoi sudditi e l’amata moglie Maria Teresa d’Austria sconvolti dall’inaspettato evento. Già prescelto quale erede al trono imperiale, fu a quel punto proprio Giuseppe, primogenito maschio, a succedere al padre, mentre il più giovane Pietro Leopoldo, che pochi giorni prima della scomparsa del genitore aveva preso in sposa l’infanta Maria Luisa di Borbone-Spagna, assunse il governo del granducato di Toscana, le cui principali città si attivarono subito per rendere omaggio al defunto con sontuose cerimonie.
A Pisa l’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano si fece carico direttamente della preparazione degli allestimenti per le pubbliche esequie in sua memoria, affidando all’avvocato Francesco Taddei il meticoloso resoconto scritto di tutti gli apparati messi in opera e la narrazione delle varie fasi della celebrazione, da cui è tuttora possibile attingere per ricostruirne gli sviluppi. I responsabili della direzione dei lavori, nominati dal Consiglio dei Dodici, furono Anton Maria Boni, commissario del convento stefaniano, Quintilio Galeotti, console del mare, e Camillo Ruschi, soprintendente generale, mentre il pisano Nicola Stasi fu incaricato della realizzazione del catafalco da allestire in Santo Stefano.
Le pompe funebri pisane per il Lorena ebbero luogo a partire dalla mattina del 19 dicembre 1765. Il portale della chiesa era stato incorniciato da festoni gialli e neri, in ossequio ai colori imperiali, ed era sormontato da una lunga iscrizione commemorativa composta da padre Odoardo Corsini, professore di Lettere presso l’Ateneo cittadino. Analoghi addobbi dominavano anche l’interno dell’edificio, comparendo nell’abside e sull’arco trionfale coronato al centro dall’arme imperiale, mentre i lati lunghi della navata «furono adornati a pittura con intercolunnj, ed arcate di architettura dorica con pilastri, e contrapilastri di marmo bianco di Carrara, formellati di mischio di Seravezza, come era tutto il restante dell’ornato». Le strutture si avviavano con intercolumni entro cui erano inseriti, uno per lato, due ovali dipinti a chiaroscuro, stagliati su fondo nero, con le personificazioni della Giustizia e della Prudenza. La postazione del nuovo granduca e gran maestro Pietro Leopoldo era installata in cornu evangelii (cioè, con spalle all’ingresso, a sinistra dell’area absidale), e quella del priore dell’Ordine in cornu epistolae (a destra). Seguivano su entrambi i lati altre arcate con fondo nero e decori gialli, con altrettanti ovati a chiaroscuro pendenti dall’alto con personificazioni di virtù, mentre negli spazi sottostanti erano stati disposti alcuni altari. La controfacciata ospitava, infine, il palco per i musici e l’intero ambiente era poi ornato dalle consuete bandiere e dai trofei guerreschi che si intervallavano tra le finestre.
Come si vede in una stampa inserita a corredo della Descrizione dell’evento compilata da Taddei, al centro della chiesa venne disposta la macchina del catafalco, innalzata su un basamento a gradoni in porfido con piedistalli in marmo su cui posavano vasi di verde antico. La parte centrale, in cima ai gradini, era composta da una balaustra sormontata da statue femminili, ciascuna rappresentante una città della Toscana, e al di sopra di tutto svettava «l’urna regale dell’estinto monarca», protetta da un ampio padiglione foderato di ermellino.
In apertura di cerimonia «sopra gli altari tutti del tempio si offerirono all’Altissimo frequenti sacrifizj, e dai moltissimi fedeli adoratori continuamente si porsero ferventi preghiere in suffragio, e riposo eterno di quell’anima augusta». Sopraggiunsero quindi i Cavalieri religiosi «con magnifico treno, e con abito da chiesa», disponendosi intorno al catafalco; alle loro spalle erano invece «il sig. Commissario, i signori Consoli del mare, ed i signori Priori della città di Pisa, tutti in abito di magistratura». Alle 10 in punto si diede inizio alla messa solenne, cantata dal sacerdote e cavaliere Anton Maria Boni, cortonese, in sostituzione dell’anziano priore della chiesa Gasparo Cerati, e accompagnata dalle composizioni musicali del napoletano Francesco Durante.
Conclusa la funzione il sacerdote officiante, seguito dal clero, pronunciò «le Assoluzioni, girando intorno all’urna sulla ringhiera dell’imbasamento», mentre Flaminio dal Borgo, cavaliere, giureconsulto, professore all’Università di Pisa e gran tesoriere dell’Ordine, recitò l’orazione funebre, «encomiando con nobile facondia le luminose et magnanime gesta dell’estinto signore». Per i tre giorni successivi la chiesa e l’intero apparato festivo vennero lasciati a disposizione del popolo, che copioso vi si recò per rendere a sua volta omaggio al sovrano scomparso.
Media gallery

1799
Celebrazioni per la liberazione dal dominio francese
Dopo la cacciata (momentanea) dei francesi nell'estate del 1799, la popolazione pisana abbatté l'albero della libertà che gli invasori avevano innalzato in Piazza dei Cavalieri e promosse cerimonie per celebrare la libertà, alle quali parteciparono attivamente anche i cavalieri dell'Ordine di Santo Stefano.
Nell’estate del 1796 le truppe napoleoniche occuparono progressivamente il Granducato, permettendo tuttavia in un primo momento a Ferdinando III d’Asburgo-Lorena di conservare, seppur soltanto formalmente, il proprio trono. Nella primavera del 1799 i francesi entrarono ufficialmente a Firenze e Ferdinando si rifugiò, in esilio, a Vienna. Terminata l’era di neutralità della Toscana, in tutte le piazze delle città furono eretti alberi della libertà, simbolo della Rivoluzione francese. Connotata da intrinseci motivi di fragilità, la conquista fu presto messa in crisi dalla seconda coalizione antifrancese. Dopo nemmeno pochi mesi, nell’estate dello stesso anno, gli austriaci e i russi arrivarono a Firenze, favoriti anche dagli attacchi che, dall’interno, la neonata Repubblica francese aveva subìto da parte di alcuni insorti aretini, i quali, al grido di «Viva Maria», avevano preso parte al movimento di reazione sanfedista all’occupazione. La liberazione dalla dominazione francese produsse eventi di giubilo in tutta la regione.
Su quanto accadde a Pisa siamo informati grazie a una relazione data alle stampe quell’anno, redatta dall’avvocato Francesco Gaeta. Si tratta di una testimonianza importante, perché ci consegna lo sguardo di esultanza di quella porzione di popolazione che, rimasta fedele ai princìpi religiosi e monarchici, aveva vissuto con profondo turbamento le politiche di laicizzazione messe in atto dai francesi, a partire soprattutto dall’abolizione degli ordini e delle corporazioni religiose. Principale bersaglio degli invasori a Pisa erano stati proprio i cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano. Le loro passate glorie, testimoniate dai vessilli turchi appesi nella loro chiesa conventuale, continuavano a essere ragione di orgoglio per molti pisani, nonché (in quel preciso contesto) un’utile prova delle vittorie della fede nella storia. Anche per questo i Cavalieri figurarono tra i protagonisti dei festeggiamenti antifrancesi.
Tra gli atti di festa, una delle prime azioni spontanee dei pisani fu, sulla scorta dei precedenti offerti dai «Viva Maria», l’abbattimento dell’albero della libertà, posto a Pisa proprio in Piazza dei Cavalieri che, già enclave cittadina di un ordine religioso-militare, era stata subito risemantizzata dai francesi con il più evidente emblema della Rivoluzione. Gaeta descrive la scena: «allorché accorso il popolo in folla sulla Piazza detta dei Cavalieri, rovesciò e distrusse il simbolo della desolazione, che vi era stato eretto, unitamente a tutti gli altri emblemi repubblicani. Fatto in pezzi l’infame albero, fu bruciato in diversi luoghi della città».
I Cavalieri e la piazza furono poi coinvolti in tutte le processioni che si susseguirono nei mesi successivi: il corteo in onore dell’immagine di Maria Vergine di sotto gli organi passò attraverso la Piazza dei Cavalieri e i membri dell’Ordine non solo parteciparono alle celebrazioni nella Cappella di San Ranieri all’interno della Cattedrale, ma organizzarono anche una propria festa in Santo Stefano. Per via dell’occupazione francese non era stato possibile onorare la ricorrenza del Corpus Domini: si decise perciò di recuperare eccezionalmente la festività il 30 luglio. La piazza venne benedetta e i Cavalieri si recarono in cappa magna alla chiesa conventuale ad ascoltare la messa, al termine della quale ebbe inizio la processione, fortemente partecipata dalla popolazione, che percorse tutta l’area urbana al canto del Te Deum. Per l’intera giornata rimase esposta per la pubblica adorazione l’ostia consacrata, e alle sei di sera il cavaliere cappellano Pietro Matani tenne un’orazione. La festa si concluse dopo i vespri con la benedizione eucaristica.
Si trattò, a ben considerare, di una gioia effimera, visto che il ripristino dell’assetto e delle tradizioni prerivoluzionarie durò pochi mesi: con il trattato di Lunéville del febbraio 1801 Ferdinando III fu costretto ad abdicare e venne creato uno stato satellite, il Regno d’Etruria, governato dai Borbone.
Media gallery

1824-1859
Le esequie di Ferdinando III di Toscana e di altri membri della famiglia granducale
Ancora per larga parte dell’Ottocento la chiesa dei Cavalieri fu teatro delle onoranze funebri concesse ai granduchi lorenesi. Tra queste si contraddistinsero nel 1824, per il particolare sfarzo, le esequie tributate a Ferdinando III di Toscana. Qualche anno più tardi, nel 1833, l’architetto pisano Alessandro Gherardesca progettò il cosiddetto ‘Catafalco dei Cavalieri’: una struttura effimera, destinata a essere impiegata al ripresentarsi di queste occasioni.
Anche dopo il passaggio al dominio lorenese, l’Ordine stefaniano aveva continuato a utilizzare sistematicamente la propria chiesa conventuale per le celebrazioni funebri dei sovrani, dallo sforzo organizzativo delle quali si legge in controluce il favore riservato ai vari membri della famiglia granducale.
Se le esequie dell’imperatore Francesco I (1765) avevano comportato da subito l’organizzazione di una complessa macchina celebrativa, molto più freddamente era stata accolta la notizia della scomparsa del successore Pietro Leopoldo (1792), il quale moriva avendo rinunciato da due anni al governo della Toscana – e quindi al ruolo di gran maestro – in favore del figlio Ferdinando III, ma soprattutto si era reso responsabile di un radicale (e mal digerito) ridimensionamento del potere stefaniano. Nella parentesi borbonica Ludovico I, re d’Etruria fra 1801 e 1803, aveva ricevuto a sua volta solenni esequie come vertice dei Cavalieri; ma fu piuttosto l’inaspettata dipartita di Ferdinando, tornato al potere nel 1814, a coinvolgere gli animi dell’Ordine, che il granduca lorenese aveva voluto ripristinare nel 1817, otto anni dopo la soppressione ad opera di Napoleone.
Ferdinando III moriva a Firenze il 18 giugno del 1824. I Cavalieri si unirono alle celebrazioni allestite in tutte le città della Toscana; durante il mese di preparazioni, Santo Stefano fu chiusa (si ufficiò «nella Cappella, detta del Santissimo Sepolcro, e per comodo del popolo fu eretto un altare amovibile nella stanza che serve di spogliatoio dei santissimi Cavalieri»). Il 16 settembre, giorno della cerimonia, partecipata dal Consiglio dell’Ordine e dai maggiori notabili pisani, all’interno della chiesa era collocato un imponente mausoleo con quattro pilastri recanti candelabri in finto bronzo e coronati da un copioso numero di lumi accesi. Al centro si ergeva un’urna sepolcrale, alla quale era appoggiata «in atteggiamento di profonda mestizia una statua di eleganti forme, e di grandezza un poco più che naturale, rappresentante la Religione di Santo Stefano, inconsolabile per la perdita dell’augusto suo gran maestro», colta nell’atto di contemplare il ritratto – senz’altro un medaglione a rilievo – del granduca. Autore dell’opera era lo scultore Tommaso Masi, allievo di Canova da tempo limitatosi al restauro e a commissioni di secondaria rilevanza. Iscrizioni latine, realizzate da Giuseppe Dini, maestro di belle lettere dei chierici, pendevano alle pareti e sopra la porta.
Dopo il requiem, cantato dal priore Giuseppe Cosi del Voglia con musiche del maestro di cappella Stefano Romani e coro dei professori, l’orazione funebre fu affidata al provveditore generale dell’Università Beniamino Sproni. Accostando riferimenti classici a slanci religiosi, egli rievocava il ritorno del granduca al governo della Toscana quale momento di sommo ripristino della pace e ne celebrava il ruolo di legislatore tollerante ma capace di decisioni ferme (fra le quali, persino la reintroduzione della pena di morte). Il professor Baccio dal Borgo aveva composto una delle sue canzoni, nella quale, in libera combinazione di endecasillabi e settenari, descriveva il pianto di due donne, compagne nel lutto: Alfea «già madre di temuti eroi» e una Guerriera «cui purpurea croce pende dal petto», ovvero Pisa e la Religione di Santo Stefano, salvata «da un odioso esiglio» per iniziativa di Ferdinando.
Il 24 marzo 1832 moriva proprio a Pisa Maria Anna Carolina di Sassonia, prima moglie di Leopoldo II, la quale, da tempo malata di tubercolosi, si era stabilita nella città toscana in virtù della sua rinomata aria salubre. Per tre giorni la salma fu esposta in Palazzo Reale, per poi essere trasportata a Firenze, con un corteo che la seguì fino a Porta Fiorentina. Nel contribuire alle celebrazioni, il 10 aprile i Cavalieri riciclavano come apparato effimero «la macchina grandiosa, che era stata in opera pel gran-duca Ferdinando III, meno del medaglione, che è stato fatto dal giovane Vallint, rappresentante al naturale il ritratto della augusta defonta col motto all’intorno ‘Lex Dei in corde ipsius’». Si tratta di Enrico van Lint (1808-1884), figlio d’arte di quel Michele che, sulla scia di Masi, aveva praticato a Pisa una lingua scultorea di capace ortodossia canoviana. Alla morte del padre (1828), Enrico aveva assunto la direzione del laboratorio di scultura di famiglia, professione alla quale affiancherà poi felicemente, da battistrada, quella di fotografo.
Dopo la messa cantata, Baccio dal Borgo dedicò alla defunta granduchessa un’orazione enfatica e di caricato patetismo, che apriva con un richiamo iperbolico proprio alla macchina celebrativa in Santo Stefano: «Qui dove grandeggia in rito solenne un sacro apparato di lutto […]; qui dove i canti e i prieghi de’ sacerdoti sul profumato altare s’innalzano; qui dove un feretro funestissimo di regali insegne coperto, addita che ogni fasto di umana grandezza si perde nell’ultimo onore di una tomba…». La granduchessa venne lodata come sovrana mite e di cristiana misericordia; in relazione a Pisa, è qui ricordato il suo impegno per far risorgere il Conservatorio di Sant’Anna sulla scia di quanto già fatto a Firenze con la fondazione del collegio femminile della Santissima Annunziata (1823). In calce all’orazione, l’editore pisano Nistri pubblicava anche l’epigrafe temporanea scritta da Giuseppe Cantini per le esequie in Santo Stefano.
L’anno successivo, il celebre architetto pisano Alessandro Gherardesca progettò un catafalco dedicato alle «annuali esequie da celebrarsi pe’ gran maestri» nella chiesa di Santo Stefano, in marmo pentelico e granito grigio e rosso, corredato di un’articolata decorazione con un bassorilievo figurato, candelabri, tazze in metallo di Corinto, leoni e altri elementi ornamentali. Del ‘Catafalco de’ Cavalieri’ si conserva il progetto originale; inoltre, nel 1838 Bartolomeo Polloni lo descrisse e lo rappresentò in una veduta dell’interno della chiesa. La struttura rielaborava formule utilizzate altrove dall’architetto e si confronta bene specialmente con l’arco trionfale eretto nel giugno dello stesso 1833 in Piazza Santa Caterina per la festa di inaugurazione del Monumento a Pietro Leopoldo. Le differenti dimensioni dei due apparati, verificabili tramite il confronto con i disegni a testimonianza di quest’ultimo evento, permetterebbero di escludere un riutilizzo diretto di quell’architettura effimera per il Catafalco, come inizialmente ipotizzato.
Le ricorrenze annuali in ricordo dei gran maestri scomparsi furono le ultime forme di celebrazioni funebri dedicate alla famiglia granducale nella chiesa. Ciò, a non voler considerare la sobrissima cerimonia tenuta il 4 marzo 1859, alla presenza di soli diciannove cavalieri, per la morte di Anna Maria di Sassonia, consorte del figlio di Leopoldo II, Ferdinando. Questi sarebbe stato nominato granduca nel luglio successivo, in ‘contumacia’, diventando solo formalmente, e per pochi mesi, l’ultimo sovrano di Toscana. Il requiem stava per suonare anche per l’Ordine, abolito dal governo provvisorio il 16 novembre.
Media gallery
1860
Plebiscito per l’annessione al Regno d’Italia
Nel marzo 1860 i cittadini della Toscana votarono l’annessione al Regno d’Italia a suffragio universale maschile. Il primo dei cinque seggi della provincia di Pisa fu allestito all’interno del Palazzo della Carovana, sede dal 1846 della Scuola Normale Superiore. Una lettera dello storico Pasquale Villari alla poetessa inglese Elizabeth Barrett Browning fornisce una preziosa testimonianza dell’evento.
L’11 e il 12 marzo del 1860, i cittadini della Toscana furono chiamati a votare il plebiscito indetto dal governo provvisorio di Bettino Ricasoli, esprimendosi sull’alternativa così espressa nel quesito referendario: «Unione alla monarchia costituzionale del re Vittorio Emanuele ovvero Regno separato». Da alcuni mesi, il granduca Leopoldo II aveva abbandonato la Toscana rifugiandosi a Vienna; i tempi parevano maturi per una consultazione popolare, a suffragio universale maschile, sull’annessione dell’ex granducato lorenese alla corona dei Savoia.
A Pisa, l’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano era stato da poco abolito, e forse anche per ragioni simboliche, oltre che per la sua centralità urbanistica, il primo dei cinque seggi fu allestito dentro Palazzo della Carovana, dal 1846 sede della Scuola Normale Superiore. In Carovana si riunirono dunque i membri del collegio della prima sezione: il gonfaloniere Francesco Ruschi, il cavalier Giuliano Prini, Antonio Giorgi, Lelio Gallizioli e Gaetano Fantoni (quest’ultimo, canonico e professore di Filologia e Lettere orientali all’Università di Pisa). I verbali, conservati dall’Archivio di Stato, descrivono le operazioni elettorali delle due giornate, con tempi che il gonfaloniere scandisce «stante all’orologio comunale della Piazza dei Cavalieri» (cioè, guardando Palazzo dell’Orologio); i vari registri, inoltre, consegnano alla memoria collettiva nome, età e professione degli aventi diritto al voto. Fra i moltissimi contadini, operai, ingegneri, scalpellini, bottegai, possidenti che varcarono le porte della Carovana per recarsi al seggio dalle varie parrocchie ad esso assegnate, non mancano i nomi di alcuni docenti dell’università. Nel pur breve registro della chiesa conventuale di Santo Stefano spicca inoltre la presenza del direttore della Normale Ranieri Sbragia (1846-1862), teologo di tendenze liberali, di Emilio Villari (allora studente, poi importante fisico a Bologna e a Napoli, 1836-1904) e del fratello Pasquale, tutti e tre con un piccolo segno apposto a conferma della votazione avvenuta.
Celebre storico napoletano, figura ‘anomala’ ma politicamente centrale nell’Italia unita, e futuro direttore della Normale, è proprio il trentaduenne Pasquale Villari (1827-1917) a fornire in una commossa lettera alla poetessa e amica Elizabeth Barrett (che con il marito aveva vissuto a Pisa nell’inverno 1846-1847), datata 12 marzo 1860, la più preziosa testimonianza della folla ammassata davanti alla Carovana e delle votazioni al suo interno. La finestra della sua abitazione «a Pisa nella ‘Torre della Fame’ del conte Ugolino, ora Casa Finocchietti in Piazza dei Cavalieri» si era rivelata un punto di osservazione privilegiato per registrare l’evento: «Alle 8 del mattino questa gran piazza fu inondata di tutto il popolo pisano che venne con ordine quasi militare, bandiere tricolori spiegate e con un silenzio solenne, con una gravità quasi religiosa» scriveva il letterato, continuando: «A poco a poco entravano in un edifizio su cui era scritto “Suffragio Universale – Sezione prima”; e poi uscivano per una porta laterale. Questo edifizio è ora la Scuola Normale, una volta era l’abitazione di quei gloriosi cavalieri pisani che tante bandiere tolsero ai barbareschi. Il modo con cui si dava il suffragio era anch’esso solenne e libero».
Nelle procedure, viste da vicino al momento del voto, Villari registrava come centrale il ruolo del «professore e canonico Fantoni, creato cavaliere dall’ex granduca, [che] aveva in mano la nota alfabetica di tutti coloro che avevano diritto a votare. Chiedeva a ciascuno il nome, acciò niuno che fosse di età minore o forestiero potesse votare, dopo ciò una guardia nazionale apriva l’urna che veniva chiusa non appena il voto segreto era deposto. Allora il canonico faceva un segno al nome di colui che aveva votato, acciò non si potesse presentare una seconda volta». Ma erano stati soprattutto la «nobiltà», la «gravità», l’«ordine» e il «silenzio» con il quale il «popolo pisano» adempiva «al suo dovere» ad aver affascinato lo studioso, e in particolare «un povero uomo impiegare un’ora a salire e scendere la scala, aiutato da due altri compagni, e sopportare dolori che lo facevano impallidire ma non gridare. Sembrava un soldato di Garibaldi; una grave e recente ferita gli aveva reso impossibile l’uso d’una gamba, quello dell’altra riusciva ancora doloroso».
Pur nel genere più intimo e informale della lettera privata, la descrizione di Villari si serve degli stessi luoghi narrativi e retorici della pubblicistica ufficiale. Anche a Firenze, secondo La Nazione del 13 marzo, al momento del plebiscito: «Non canti, non grida, non moti tumultuarii, non affaccendarsi incomposto, ma silenzio, calma solenne, e quasi religioso raccoglimento […] Se non erano le folte bandiere che adornavano ogni casa ed ogni contrada, niuno sarebbesi accorto». Se a Pisa Villari è colpito dalla gravitas di un elettore ferito alle gambe, a Vicopisano il delegato Alfani si commoveva invece nel relazionare di «tre poveri vecchi ottuagenari impotenti a trascinare il debole fianco […] e giunti al palazzo municipale discenderne sorretti da alcune persone che li hanno guidati all’urna».
I dati e i resoconti confermano il quadro di una partecipazione ordinata, con punte di entusiasmo e nessun dissenso significativo. È tuttavia importante ricordare che il plebiscito toscano si configurò come un’operazione politica sostanzialmente guidata dalla frangia moderata del fronte risorgimentale, e coinvolse anche a Pisa – come dimostrato da Danilo Barsanti – una cittadinanza organizzata e spesso direttamente indirizzata al voto dalle rappresentanze politiche, dai proprietari fondiari e dai membri del clero compartecipi, con solo una porzione di popolo emotivamente coinvolta dall’appuntamento. Nondimeno, in città la propaganda studentesca contribuì a portare alle urne oltre il novanta per cento degli aventi diritto; un dato assai alto rispetto al resto della Toscana, dove comunque, fra i votanti, le schede a favore dell’unione rappresentarono una schiacciante maggioranza. Il 17 marzo, Ricasoli annunciava l’annessione al Regno d’Italia. Al seggio di Palazzo della Carovana, sui 2622 iscritti, avevano votato 2451 unionisti e 59 separatisti (più 32 schede nulle o bianche).
Storicamente vera, e da leggersi alla luce dell’indignazione contro l’arcivescovo Corsi (in aspro contrasto con il governo provvisorio), è infine la notizia che chiude la lettera di Pasquale Villari: «dimenticavo di dirle che tutte le case avevano bandiere tricolori. Un solo grandissimo palazzo era con tutte le finestre chiuse – quello dell’arcivescovo – sulle mura però v’era: Viva V[ittorio]. E[manuele] II. scritto dal popolo 1000 volte». Il palazzo è così ricordato anche dal giornalista Carlo Pisani, in una violenta pagina antimazziniana del 1861: «La balordaggine del tentativo mazziniano qui ha indignato tutti. […] Tutta la Toscana ha scritto ad ogni passo – Viva il nostro Re Vittorio Emanuele. – A Pisa ne han coperto letteralmente il palazzo dell’Arcivescovo. […] Figuratevi il fele che sprizza dalle anime dei vergini intelletti concretizzati nel verbo! – Questo sì che deve loro far l’effetto di passeggiare sopra una crosta vulcanica [corsivo nell’edizione originale]».
Fra l’altro, si ironizza qui sulla metafora della ‘crosta vulcanica’ pronta a rompersi per la situazione risorgimentale, spesa da Giuseppe Mazzini all’inizio del Proclama del 6 febbraio 1853 («La superficie dell’Europa, dalla Spagna a noi, dalla Grecia alla santa Polonia, è crosta vulcanica: dorme al disotto una lava») e prima ancora nella capitale lettera a Carlo Alberto del 1831 («Sire! non vi lasciate illudere da’ cortigiani […] voi passeggiate sopra un vulcano»). È proprio a quest’immagine che fa riferimento Villari nella lettera a Barrett: «io lascio a lei pensare con che animo io mi occupi del passato – quando ruppe tutto ai nostri piedi la lava del Vulcano». La poetessa era stata a sua volta attivissima nella causa risorgimentale, e assiduamente – e spesso polemicamente – discute nel suo epistolario la prospettiva del fondatore della Giovine Italia e della Società degli amici d’Italia.
Esercitato il suo diritto di cittadino, lo studioso napoletano, neoprofessore all’Università di Pisa, tornava «nella Torre della Fame ad apparecchiare le mie lezioni». Si trattava del suo primo corso, fra storia universale e filosofia della storia: frequentatissimo, e che pure – lo testimoniano le sue lettere – lo tormentava, parendogli di non riuscire a trovare le parole adatte per quel pubblico variegato. Tanto più, un’intelligenza come la sua non poteva non percepire l’«ironia inestinguibile» di stare osservando dalla finestra la Storia nel suo farsi, quando l’edificio che per tre secoli era stato il fiore all’occhiello dei Cavalieri di Santo Stefano diventava il teatro di un passaggio epocale, ospitando la chiamata a raccolta di quelle spinte appassionate e convulse, diverse e talora contrapposte, che costituirono il Risorgimento.

1920
Comizio di Errico Malatesta
Errico Malatesta, figura autorevole del movimento operaio e del panorama anarchico internazionale, tenne un comizio il 31 gennaio 1920 dalla scalinata del Palazzo della Carovana in una Piazza dei Cavalieri gremita di lavoratori e bandiere.
Il Primo conflitto mondiale si concluse nel 1918, portando con sé un’eredità di fratture sociali e politiche, perdite di vite umane e crisi economica. I sommovimenti sociali, evidenti già durante la guerra, vennero esacerbati da una situazione ulteriormente complicata dalla disoccupazione, dal ritorno dei reduci dal fronte, dall’emergere di nuove miserie a cui si aggiunse lo smantellamento del sistema (presente in tempo di guerra) dei sussidi e del controllo dei prezzi, e persino una crisi sanitaria dovuta all’epidemia di spagnola. La guerra consentì che le contraddizioni sociali emergessero con maggior forza e comportò un importante elemento di novità: l’irrompere delle masse nella scena pubblica. Durante quello che viene comunemente definito «biennio rosso» del 1919-1920 – in cui in realtà vi fu una varietà di componenti e colori politici diversi –, in Italia si verificarono forti conflitti che sfociarono in lotte contadine e scioperi operai, tumulti annonari e moti contro il caroviveri. Queste proteste di piazza trovarono un supporto fondamentale nelle organizzazioni sindacali e socialiste, mentre la risposta delle istituzioni dello Stato liberale oscillò tra un iniziale e moderato processo riformista e una dura controffensiva repressiva.
Fu in un simile contesto che Errico Malatesta, ‘nota persona’ (come venne definita nei promemoria degli organi di Pubblica Sicurezza), rientrò alla fine del 1919 in Italia da Londra, dove si era rifugiato nel 1914 a seguito del mandato di cattura che lo aveva colpito per aver partecipato come agitatore alle lotte della Settimana rossa. Non solo un fine teorico politico dell’anarchismo internazionale, ma anche un grande agitatore, appena rimpatriato avviò un giro di conferenze, comizi e riunioni. Nonostante avesse ormai più di sessant’anni, si mosse senza sosta lungo l’Italia, accolto ovunque da piazze stracolme di persone. Significativa della statura morale del personaggio è la lettera dal titolo Grazie, ma basta, che affidò nella pubblicazione al settimanale Il Libertario in cui, appellandosi ai suoi compagni e ringraziandoli, chiese di allentare le celebrazioni alla sua persona perché «è cosa politicamente pericolosa ed è moralmente malsana per l’esaltato e per gli esaltatori». L’obiettivo di Malatesta era la rivoluzione, intesa come forma insurrezionale e di violenta rottura dell’ordine politico ed economico dello Stato borghese, in favore dell’emancipazione dei lavoratori e della liberazione dell’umanità tutta.
Tra le «grandiose accoglienze rivoluzionarie a Errico Malatesta», vi fu appunto quella pisana, che si svolse proprio l’indomani dello sciopero nazionale dei ferrovieri e dei postelegrafonici. Il clima di quei giorni di gennaio in città era molto teso perché nella notte tra il 20 e il 21 si erano verificate azioni violente e arresti da parte di alcuni gruppi di civili armati. La città aveva prontamente e spontaneamente risposto proclamando lo sciopero generale fino alla liberazione degli arrestati. Il 31 gennaio Malatesta venne accolto da gente entusiasta già all’arrivo col treno in stazione, nonostante il breve preavviso dato sulla sua venuta. Secondo la stampa anarchica locale un «applauso scrosciante, sgorgante dall’anima pura e ribelle del nostro popolo, salutò l’uomo dalle cento battaglia [sic] e il grido di ‘Viva Malatesta’, il condottiero della Rivoluzione italica, si ripercosse nell’aria. Preceduto da molte bandiere si formò poi subito il corteo, che al canto di inni ribelli si portò in Piazza dei Cavalieri», dove venne improvvisato il comizio sullo scalone d’ingresso del Palazzo della Carovana. Malatesta intervenne dopo gli anarchici e i rappresentanti della Camera del lavoro, dei socialisti e dei ferrovieri. Il suo discorso fu chiaro e diretto: «la rivoluzione dovrà farla il popolo», con la convergenza e la concordia di tutti gli elementi della sinistra sovversiva, e doveva essere fatta non «a braccia conserte, […] con l’abbandonare le macchine o le fabbriche», ma «si dovrà combattere opponendo armi ad armi», pur senza trascurare «lo studio del problema dell’alimentazione all’indomani della distruzione dello Stato borghese».
Nei giorni successivi, mentre riprendeva il viaggio di propaganda, Malatesta venne arrestato a Tombolo, tra Pisa e Livorno, e poi velocemente liberato a seguito della reazione di forte protesta e sciopero generale in Toscana. Coerentemente con gli ideali propagandati per tutta una vita, nei mesi e negli anni che seguirono continuò a promuovere la rivoluzione sociale, senza tuttavia vederne mai la realizzazione.
Media gallery

1925-1943
La Battaglia del grano
Durante il regime fascista Piazza dei Cavalieri ospitò la festa del grano: una delle manifestazioni di irreggimentazione delle masse connesse alla campagna voluta da Mussolini a partire dal 1925 per aumentare la produzione nazionale di cereali, nota come ‘Battaglia del grano’. Nell’area urbana venivano sottoposti a trebbiatura covoni di cereali con moderne macchine agricole, ad esaltazione del lavoro rurale e del progresso tecnologico.
Come tutti i regimi totalitari, il fascismo propugna una tenace politica di irreggimentazione delle masse. Essa viene perseguita (anche) attraverso una strabordante (e studiata) serie di momenti di aggregazione: adunate, ‘cerimonie patriottiche’, manifestazioni, discorsi, promossi dal regime nazionale o da una della miriade di associazioni in cui si organizzava la vita associata dell’epoca. All’interno di tale strategia (non priva di forme di coercizione) lo spazio pubblico e in particolare la piazza assume un’importanza particolare.
Assieme ad altri luoghi della città (Piazza del Duomo, in cui si svolse una celebre visita di Mussolini nel 1926 e Piazza Santa Caterina, che accolse la famiglia regnante nel 1925) Piazza dei Cavalieri rivestì un ruolo privilegiato. Tra le molteplici manifestazioni che qui ebbero luogo, tra le più peculiari vi è senz’altro quella legata alla promozione della nota ‘Battaglia del grano’. Annunciata da Benito Mussolini in un comunicato dell’11 giugno 1925 e rilanciata nel 1935 per rispondere al nodo sanzionatorio promosso dalla comunità internazionale, la campagna si prefiggeva il compito di aumentare la produzione nazionale di cereali. Se da un lato tale obiettivo rispondeva a esigenze economiche (autosufficienza alimentare, equilibrio nella bilancia dei pagamenti, sostegno dei produttori italiani) e politiche (come riporta uno degli artefici della campagna, Francesco Todaro, al grano il regime fascista imputava nientemeno che «l’indipendenza nazionale in pace e la vittoria in guerra»), dall’altro rispondeva a profonde ragioni ideologiche. Sotto lo slogan «bisogna ruralizzare l’Italia», il regime infatti mescolava in modo contradditorio la propria componente tradizionalista e reazionaria (fondata sui miti del ritorno alla terra, della virilità e moralità della vita agreste, dello strapaese e dell’idillio bucolico) con quella modernista affascinata al contrario dallo scatto tecnologico e dalla civiltà industriale.
La ‘Battaglia del grano’ allora si componeva di una molteplicità di manifestazioni e di incontri ramificati come sempre tra centro (Roma) e periferia. Nella capitale, nella sede del teatro Argentina, si svolgeva ad esempio (tra ottobre e dicembre) la proclamazione dei vincitori (i «veliti», secondo la definizione dello stesso Mussolini) del Concorso nazionale per la vittoria del grano, modificato dal luglio del 1934 in Concorso nazionale del grano e dell’azienda agraria, che premiava le aziende più produttive alla presenza dello stesso capo del governo, mentre nelle singole province si replicava la celebrazione su base locale. Pisa, ad esempio, nella terza edizione del premio (1927) ‘vantò’ un alto numero di menzioni. Il regime poi organizzava, sempre per tramite dei fasci locali, le cosiddette ‘cattedre agricole ambulanti’ (laboratori dimostrativi tesi a presentare ai coltivatori le più aggiornate tecniche produttive), ma anche convegni di divulgazione scientifica, mostre, proiezioni cinematografiche.
Come in altre città italiane anche a Pisa si celebrava, tra giugno e luglio (in coincidenza delle ultime fasi di raccolta), la festa del grano. Nella piazza venivano collocati dei covoni poi sottoposti a trebbiatura (procedura che consiste nella separazione della granella dalla paglia e dalla pula). Tale operazione veniva svolta da macchinari automatizzati, impiegati a scopo dimostrativo e pubblicitario. In una delle foto a corredo della scheda, in una piazza gremita di vessilli cittadini, si nota un modello della ditta S.A. Balduzzi e Rovida. In uno dei capolavori urbanistici del Manierismo italiano, al cospetto del fiore all’occhiello dell’accademia nazionale (la Scuola Normale), il fascismo coniugava una tradizione ancestrale (la festa del raccolto) all’innovazione tecnologica e alla promozione aziendale. Una delle tante forme in cui si esprimeva l’eclettismo, in molti casi scellerato, del regime al potere in Italia tra il 1922 e il 1943.


Media gallery

1935-1940
Parate fasciste delle organizzazioni giovanili
Sotto il fascismo Piazza dei Cavalieri divenne un luogo centrale della ritualità del regime, che vi ospitò adunate e parate, molto partecipate dalla popolazione durante gli anni Trenta. Tra questi eventi di particolare rilevanza furono quelli che coinvolsero la gioventù, facendola sfilare in gruppi distinti per età e genere, secondo le coordinate previste dal disciplinamento fascista della società.
Pisa, come molte altre città italiane, attraversò un periodo di forti squilibri e crescenti tensioni sociali e politiche dopo la fine della Prima guerra mondiale. In questo clima di progressiva instabilità, il 28 aprile 1920 si tenne in Borgo Stretto la prima assemblea costitutiva del movimento fascista. Composto inizialmente da giovani ex-combattenti, ex-arditi, studenti, membri della piccola e media borghesia agraria, disoccupati e scontenti, il Fascio pisano nel corso degli anni Venti adottò una linea progressivamente più violenta, senza mai perdere il sostegno sia dell’establishment locale che delle autorità militari, e vedendo esponenzialmente crescere il numero dei propri iscritti, che raggiunse nel 1939 circa 34.000 adesioni. Questa crescita rifletteva non solo il consolidamento del potere fascista in Italia, ma anche la sua capacità di radicarsi profondamente proprio nella società pisana, sia grazie a una combinazione di violenza e propaganda, sia grazie al sostegno delle élite locali.
Uno dei personaggi chiave del fascismo locale fu Guido Buffarini Guidi che, dopo essere stato podestà dal 1926 al 1933, divenne sottosegretario all’Interno: un ruolo che mantenne fino alla caduta della dittatura. Se la sua leadership contribuì a consolidare il potere fascista in città, questo trovò un suo naturale palcoscenico in Piazza dei Cavalieri, dove lo scalone già vasariano del Palazzo della Carovana si trasformò in un vero e proprio palco per parlare tramite un microfono a tutta la popolazione davanti riunita. Eventi per celebrare la cosiddetta ‘battaglia del grano’ o per commemorare la marcia su Roma (come attestano alcuni scatti del 28 ottobre 1935, con un’innumerevole folla) avevano abitualmente luogo in quest’area urbana, che nel ventennio fascista avrebbe registrato, dopo più di due secoli privi di sostanziali novità, importanti aggiornamenti edilizi, tra i quali il rinnovo delle due ali laterali della chiesa di Santo Stefano e l’ampliamento del Palazzo della Carovana avvenuto sotto il commissariato del filosofo Giovanni Gentile (1928-1933).


Tra le diverse manifestazioni che si celebravano in questa Piazza di particolare rilievo furono le parate, non solo militari ma anche civili. Si trattava di momenti di aggregazione e cerimonie di passaggio che mobilitavano ingenti settori della popolazione e trovavano una delle espressioni più visibili nelle sfilate delle diverse organizzazioni giovanili.
Il disciplinamento fascista della società, secondo generi, generazioni e occupazione lavorativa, trovò nell’organizzazione capillare della gioventù uno dei suoi ambiti maggiormente riusciti, grazie all’istituzione, fin dal 1926, dell’Opera Nazionale Balilla: un ente autonomo incaricato, come unico soggetto legittimo su tutto il territorio nazionale, di educare e assistere i bambini e ragazzi fino ai diciotto anni, ovvero fino all’ingresso nei ‘Fasci Giovanili di Combattimento’ (dal 1937 ribattezzati ‘Gioventù Italiana del Littorio’) come ‘Giovani Fascisti’. Con un decreto del 1934 l’Opera perfezionò la propria organizzazione articolando tre categorie distinte di disciplinamento per i maschi: i ‘Figli della lupa’ (sei-otto anni), i ‘Balilla Moschettieri’ (otto-quattordici) e gli ‘Avanguardisti’ (quattordici-diciotto). Il regime mantenne separate le strutture di inquadramento maschili da quelle femminili, riservando loro finalità educative e formative diverse. Un’analoga organizzazione era dunque prevista anche per le bambine: prima ‘Figlie della Lupa’, ‘Piccole Italiane’ dagli otto ai quattordici anni, poi ‘Giovani Italiane’ e dai diciassette anni ‘Giovani Fasciste’. Al compimento del ventesimo anno di età le giovani donne potevano entrare nei Fasci Femminili. A Pisa, nel 1940, il 23% delle ragazze tra i quindici e i diciassette anni risultava iscritta alla ‘Gioventù Italiana del Littorio’.
Varie testimonianze fotografiche dell’epoca ci presentano Piazza dei Cavalieri gremita di gente intenta ad assistere a parate dal carattere militaresco e autoritario, nelle quali diversi gruppi anche giovanili sfilano rigidamente distinti per età, genere e uniforme. In queste occasioni, le ‘Figlie della Lupa’ indossavano una camicia in piqué bianco a maniche lunghe, una gonna in tessuto nero, calze bianche e un berretto in lana. Le ‘Giovani Fasciste’ vestivano un tailleur nero, camicia bianca e calze color carne. I ‘Balilla Moschettieri’ sfilavano con un fez di lana nera, camicia di cotone nero, pantaloncini corti e calzettoni grigio-verde. Infine, i ‘Giovani Fascisti’ indossavano una bustina di tipo militare in tessuto grigio-verde, camicia nera, pantaloni alla zuava e uose bianche lunghe. Nel corso della parata, ogni passaggio di testimone tra le organizzazioni giovanili rappresentava un simbolico atto di continuità. Attraverso un gesto rituale, come un abbraccio, i rappresentanti e le rappresentanti di ogni organizzazione sancivano il passaggio dal proprio ruolo al grado successivo, consentendo così il progredire della fascistizzazione delle nuove generazioni.




A Pisa come nel resto del territorio italiano il Partito e le sue numerose organizzazioni intesero permeare la vita cittadina, occupando una parte significativa della quotidianità. Il progetto fascista, concepito e idealizzato da Mussolini e dai suoi sostenitori e sostenitrici, implicava una visione biopolitica della nazione, volta a inquadrare spiritualmente e materialmente la società tutta. Durante il ventennio, le cerimonie in Piazza dei Cavalieri, emblematiche della ritualizzazione della politica fascista, contribuirono a rafforzare anche a Pisa l’inquadramento della popolazione in una struttura gerarchica, volta a perpetuare l’ideologia di regime. Per questi eventi la mobilitazione dei cittadini raggiunse, di fatto, nel corso degli anni Trenta, numeri e livelli senza precedenti, tanto da far trasformare l’area urbana da luogo centrale della vita civica in uno spazio di partecipazione collettiva: uno spazio sacro e simbolico, dove una «massa liturgica» rigidamente organizzata e disciplinata celebrava periodicamente i riti della patria in una vera e propria religione civile della nazione.
Media gallery

1967-1968
Le proteste degli studenti
Nel febbraio 1967 studentesse e studenti avviarono una fase di messa in discussione di un modello di università e di società che non li soddisfaceva e portarono le loro rivendicazioni direttamente in Piazza dei Cavalieri, dando inizio a un uso di quest’area urbana come luogo di manifestazione del dissenso costante ancora nei due anni successivi.
In occasione della conferenza dei rettori fissata per l’11 febbraio 1967 a Pisa, studentesse e studenti decisero di occupare il Palazzo della Sapienza e protestare contro il cosiddetto ‘Piano Gui’: la proposta di riforma dell’università, voluta in quel momento dal Governo, che prevedeva una sua riorganizzazione strutturale con l’introduzione tra l’altro della differenziazione dei percorsi di formazione in base alle prospettive professionali, ed era stata giudicata da sinistra insufficiente a soddisfare le richieste avanzate di trasformazione in senso democratico del mondo accademico.
A partire dal 7 febbraio, gli occupanti promossero una serie di discussioni sul sistema universitario e sulle sue forme di rappresentanza, che portarono all’elaborazione collettiva del cosiddetto Progetto di Tesi del sindacato studentesco (o Tesi della Sapienza), con cui si affermava la necessità di un ruolo decisionale della componente studentesca nella propria formazione e si chiedevano nuovi metodi di democratizzazione del sistema universitario attraverso le assemblee. A partire dalla rivendicazione teorica della figura dello studente alla stregua del lavoratore («lo studente è un lavoratore e, come tale, se produce, ha diritto al salario, e, se non produce, non ha diritto di restare all’interno dell’università»), nelle Tesi venne esposta la pretesa di un diritto allo studio come strumento democratico che permettesse l’accesso all’università, azzerando i limiti di classe, e come contestazione del modello capitalistico, trovando proprio nel collegamento con le lotte sindacali e operaie un elemento di novità rispetto al filone delle mobilitazioni studentesche degli anni precedenti, in una saldatura sollecitata anche dal processo di smantellamento e deindustrializzazione delle fabbriche in atto.
L’occupazione della Sapienza a Pisa ebbe un respiro nazionale e un’attenzione mediatica senza precedenti, non senza tensioni: da una parte dovute ai contrasti con le autorità accademiche che venivano contestate, dall’altra per l’opposizione della frangia conservatrice della componente studentesca (con elementi provenienti anche dai gruppi neofascisti del Fronte universitario d’azione nazionale), che non appoggiava la protesta e la conseguente interruzione delle lezioni. Nella notte dell’11 febbraio, poche ore prima dell’inizio della conferenza istituzionale, a seguito dell’intervento della polizia per lo sgombero dell’occupazione, studenti e studentesse si riversarono in Piazza dei Cavalieri, dove misero in atto uno dei primi sit-in della storia dei movimenti in Italia.



Di quello che verrà in seguito definito ‘il lungo Sessantotto’, con cui si apriva una fase di ricerca di rinnovamento a tutto tondo della società che durò fino agli anni Settanta coinvolgendo anche movimenti femministi, studenti delle scuole superiori, sindacati e operai, furono attori principali in Italia i ventenni della prima generazione nata dopo la fine della Seconda guerra mondiale, entrati all’università in un contesto di processi in movimento che, dagli atenei americani fino all’Europa, aveva assistito all’esplosione di un’ondata di ribellione giovanile politica e culturale con l’opposizione in massa alla guerra del Vietnam e alla segregazione razziale dei neri d’America, ispirata dal modello del rivoluzionario Ernesto ‘Che’ Guevara, dal Libretto rosso e dalla rivoluzione culturale cinese, e preoccupata per il golpe dei colonnelli in Grecia e per i carri armati sovietici a Praga. Per quella generazione il ’68 fu un momento di formazione sociale, culturale e politica, rappresentando infine una fucina per la futura classe dirigente politica del Paese.
Di quelle proteste Piazza dei Cavalieri fu a Pisa uno dei principali teatri: sede per convocare i concentramenti, oppure punto di passaggio per i percorsi dei cortei o di arrivo a conclusione della giornata. Così avvenne ad esempio il 24 novembre 1968, per la marcia cittadina contro la guerra in Vietnam promossa dal Partito Comunista Italiano e dal Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, come ricorda un manifesto di propaganda politica ancora conservato presso la Biblioteca Franco Serantini, insieme ad altra documentazione che conferma i temi caldi di questa stagione: dalle manifestazioni di sostegno degli operai della Saint Gobain e della Marzotto in lotta in autunno fino alla solidarietà alle dipendenti dei magazzini Upim in sciopero nel dicembre. Si trattava di volantini che, possiamo immaginare, venivano distribuiti anche in quest’area urbana, dove non mancarono attività di contro-protesta, come provano i cartelli inquadrati da varie foto dell’epoca, ad esempio con la scritta «no ai cinesi», per esprimere in senso dispregiativo una presa di distanza dagli studenti del movimento, considerati radicali e associati alla rivoluzione culturale cinese.
L’importanza di Piazza dei Cavalieri in questo biennio caldo non fu d’altra parte dettata solo dalla sua centralità nello spazio cittadino, ma soprattutto dal suo essere un vero e proprio fulcro tra le direttrici dei poli universitari presenti a Pisa: a un passo dai luoghi in cui gli studenti svolgevano le lezioni e (soprattutto) vivevano. Oltre alle dimore studentesche storiche qui già presenti (il Palazzo della Carovana e il Collegio Puteano), dobbiamo infatti ricordare come sia il Palazzo dell’Università fosse stato nel dopoguerra destinato ad alloggio con il nome di Collegio Pacinotti, sia annessa alla piazza fosse stata da poco costruita la Casa dello Studente “Aldo Fascetti”, usata in questi anni come sede di assemblee e di cicli di conferenze a tema.
Media gallery

1968-1969
La Festissima degli studenti universitari
Come altri luoghi della città, Piazza dei Cavalieri ospitava il passaggio della Festissima delle Matricole, l’annuale appuntamento goliardico per il quale studentesse e studenti dell’ateneo toscano allestivano carri e mascherate, coinvolgendo la cittadinanza. Così avvenne anche nel biennio 1968-1969.
Così denominata per il carattere giocoso e ironico dell’evento, la cosiddetta ‘Festissima delle Matricole’ costituiva, ancora nella Pisa della seconda metà degli anni Sessanta, un appuntamento annuale molto atteso e di grande rilievo: con l’inizio dell’anno accademico, infatti, studenti e studentesse dell’Università organizzavano questo momento di svago collettivo, che si configurava come una sorta di ‘carnevale fai-da-te’, capace di ravvivare lo spirito dell’intera cittadinanza. Promossa dagli iscritti di varie facoltà, riconoscibili dai colori dalla feluca (un copricapo di reminiscenza medievale) indossata dai giovani partecipanti, la processione si snodava sui lungarni per raggiungere Piazza Garibaldi, dove si assisteva a scherzi e a canzonature. La festa, successivamente, si estendeva da Borgo a Piazza dei Cavalieri, fino allo stadio, animata da giochi e gare di ogni genere: dalle corse nei sacchi al palio dei ciuchi. Un gran numero di pisani riempiva le strade e le piazze, seguendo gli ingegnosi e imponenti carri allegorici sopra i quali i goliardi sfoggiavano ironicamente travestimenti e costumi d’epoca. Anche la statua di Cosimo I de’ Medici poteva essere impropriamente coinvolta nella festa, prestandosi a indossare ridicoli travestimenti o a reggere, invece del bastone di comando, cartelli con improbabili frasi in latino.


Prerogativa intellettuale per secoli di coloro che avevano il privilegio di approfondire gli studi, la goliardia ha avuto da tradizione come mezzo di espressione la poesia, il canto, la prosa, il teatro e il disegno. Nel caso di Pisa, una città così profondamente connotata dalla presenza fin dal Medioevo dell’Università e di collegi accademici, animazioni goliardiche hanno rappresentato nel tempo un elemento qualificante della cultura locale, soprattutto con l’espansione ottocentesca dell’ateneo. Fu nei primi anni del Novecento, in particolare, che gli organizzatori della vita goliardica pisana concepirono l’idea di fissare un momento dell’anno in cui mettere in scena giocose manifestazioni che arrivassero a coinvolgere anche la cittadinanza. Nacque così la Festissima delle Matricole, contraddistinta da una sfilata di carri allegorici delle varie facoltà, ispirata al modello del Carnevale di Viareggio già tardo ottocentesco, così come dalla recitazione di operette (la più celebre fu Addio giovinezza!) e da una pubblicazione intitolata come l’evento. Il ritorno degli studenti all’Università dopo la Prima guerra mondiale segnò una ripresa delle attività goliardiche, in particolare grazie al Crocchio Goliardi Spensierati (CGS). Ma l’avvento del fascismo, con la nascita del Fascio pisano nel 1920, la fondazione l’anno successivo dei Gruppi Universitari Fascisti (GUF) e la Marcia su Roma nell’ottobre del 1922, sollecitò la repressione e lo smantellamento delle organizzazioni studentesche antifasciste e apolitiche, di fatto ridimensionando le attività dei goliardi, che divennero sempre più rarefatte. Fu solo dopo l’ingresso degli Alleati a Pisa, che un gruppo di giovani studenti tornò a costituire, presso il Palazzo della Sapienza il 6 dicembre 1944, un’associazione con l’intento di dare nuovo impulso alla vita universitaria: l’Unione Goliardica Pisana (UGP), la prima organizzazione studentesca italiana del dopoguerra, che svolse un ruolo determinante nel sostenere l’aggiornamento dell’ateneo dopo la devastazione bellica.
Nella seconda metà degli anni Cinquanta, i profondi mutamenti che investirono l’Università e, più in generale, il tessuto sociale e culturale della città contribuirono a ridefinire le aspirazioni del corpo studentesco, sempre più orientate verso il dibattito politico, l’impegno civile e la critica ai modelli accademici tradizionali. La goliardia pisana risentì di queste trasformazioni, perdendo progressivamente il ruolo centrale che aveva occupato nella vita universitaria. Nel biennio caldo 1968-1969, la Festissima delle Matricole ebbe, ad esempio, ancora luogo, continuando a offrire un momento di accoglienza per le nuove matricole, ma senza più prevedere la partecipazione delle storiche organizzazioni goliardiche. Dalle immagini ancora conservate dell’evento, che si tenne in quei due anni, risulta chiaramente come anche tematiche allora attuali nel dibattito pubblico, quali la condanna dei fascismi e la critica alla guerra, trovassero spazio nel corteo, per quanto in un’evidente chiave di scanzonata ironia, ben diversa dal registro che stava caratterizzando proprio in quel momento le manifestazioni di protesta in piazza degli studenti per il ’68.


Media gallery

1979
Festeggiamenti per il Pisa in Serie B
Nel giugno 1979, Romeo Anconetani, alla guida del Pisa Sporting Club da meno di un anno, condusse la squadra cittadina alla promozione in Serie B. Questo primo successo della sua presidenza suscitò grande entusiasmo in città e per celebrare l’importante traguardo come luogo di ritrovo da tifosi e tifose fu scelta Piazza dei Cavalieri, dove venne imbandita una lunga tavolata e furono distribuiti a tutti i partecipanti «zuppa e vino».
La vicenda del Pisa Sporting Club si distingue per la lunga durata e per una significativa valenza storica. Fondata nel 1909 e contraddistinta da una divisa sociale nero-azzurra, la società riuscì ad affermarsi come principale rappresentante calcistico della città e, dopo aver conquistato il campionato toscano del 1914-1915, a distinguersi nel primo dopoguerra, partecipando alla finale del campionato italiano, tenutasi a Torino nel luglio del 1921. Nel frattempo, nel 1919 venne inaugurato anche lo stadio di Pisa ancora in uso, appena fuori Porta a Lucca: l’Arena Garibaldi. Dopo un periodo di declino, culminato, alla fine degli anni Venti, con la retrocessione in Terza Serie, nel secondo dopoguerra la società sperimentò un’alternanza di risultati: un’ulteriore retrocessione in Quarta Serie agli inizi degli anni Cinquanta, quindi la promozione in Serie A nella stagione 1967-1968, infine l’arretramento di nuovo nelle categorie inferiori, che sollecitò una trasformazione significativa nella sua leadership. Questo cambiamento si concretizzò nell’estate del 1978 quando Romeo Anconetani, nato a Trieste nel 1922, rilevò la quadra, rimanendovi alla presidenza per sedici anni, fino al 1994. Sotto la guida del ‘presidentissimo’, il Club raggiunse successi prestigiosi – come la conquista della Serie A nel 1982 e della Mitropa Cup nel 1988 –, risollevandosi in pochi anni.
Fin dagli esordi della sua carriera negli anni Cinquanta, Anconetani si era distinto come figura poliedrica e innovativa nel panorama calcistico italiano, mostrando una particolare attenzione per le esigenze del pubblico: dall’istituzione dei ‘treni speciali’ per tifosi e tifose all’introduzione della prevendita dei biglietti presso i botteghini diversi giorni prima dello svolgimento effettivo della partita. Questa attenzione verso la tifoseria e la comunità cittadina si manifestò anche dopo la promozione in Serie B del Pisa, al termine di otto stagioni in cui l’obiettivo era stato mancato. L’attesa vittoria contro la Paganese il 9 giugno 1979 scatenò un’ondata di entusiasmo nel capoluogo toscano, con festeggiamenti spontanei che videro «cortei di auto e scooter con le bandiere nerazzurre» invadere piazze e strade, in «una festa assordante andata avanti fino al mattino», come riportato dai quotidiani locali. Qualche giorno più tardi, il 14 giugno, con il rientro della squadra, Anconetani decise di festeggiare la vittoria, come promesso diversi mesi prima ai microfoni di Radio Pisa International, organizzando una festa collettiva lungo le strade della città, culminante in Piazza dei Cavalieri.
L’area urbana non solo venne animata da un tripudio di bandiere e striscioni appoggiati ai suoi principali palazzi, ma accolse anche la sfilata di fantocci allegorici vestiti con la maglia nero-azzurra, accompagnati da un’ampia folla di tutte le età. Inoltre, come spesso avveniva a Pisa nel corso di manifestazioni spontanee, la statua di Cosimo I de’ Medici fu impropriamente coinvolta nelle celebrazioni, trasformandosi a sua volta nel monumentale fantoccio di un tifoso, con sciarpa sopra la corazza marmorea e bandiera della squadra sventolate. Ma soprattutto la piazza si trasformò nello scenario di un insolito banchetto: prendendo parte attiva all’evento, lo stesso presidente, affiancato dagli ex dirigenti e dall’allenatore Pier Luigi Meciani, indossando un grembiule da cucina, offrì ai quasi tremila partecipanti una porzione di zuppa e un bicchiere di vino.
I quotidiani locali riportarono l’evento con grande entusiasmo nei giorni successivi, parlando di «tremila persone partecipanti all’apoteosi nerazzurra ieri sera in Piazza dei Cavalieri» e restituendo così l’immagine di una città in festa, compatta nel celebrare la propria squadra. A scandire il ritmo della serata contribuì anche uno slogan divenuto simbolico, risuonato nella piazza addobbata di manifesti e striscioni: «Dalla C siam decollati, per la B transiteremo, serie A ci rivedremo».
Media gallery

1979
Prima manifestazione italiana dell’orgoglio gay
Il 24 novembre 1979 partì da Piazza dei Cavalieri, per percorrere le vie, le piazze e i lungarni della città, la Manifestazione nazionale contro la violenza sugli uomini e sulle donne omosessuali, organizzata dal Collettivo Omosessuale Orfeo di Pisa. L’evento è considerato la prima marcia italiana dell’orgoglio gay.
Nel giugno del 1969, il bar Stonewall Inn, punto di riferimento delle comunità omosessuali e transessuali del Greenwich Village, divenne lo scenario di una serie di violenti scontri tra i propri frequentatori e frequentatrici e la polizia di New York. Sull’onda dei cosiddetti ‘Moti di Stonewall’, che rappresentarono simbolicamente il momento di nascita dei movimenti LGBT+ contemporanei, anche in Italia iniziarono a prendere forma e a organizzarsi gruppi di omosessuali, per confrontarsi collettivamente e reagire all’escalation di violenza omofoba. Nella primavera del 1971, in particolare, venne fondato a Torino il Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano (acronimo F.U.O.R.I.), in cui confluirono in seguito anche altre realtà gay e lesbiche della Penisola. Tra le iniziative, il F.U.O.R.I. chiamò a raccolta militanti da tutta Italia nel 1972 a Sanremo per protestare contro il primo Congresso internazionale lì indetto tra il 5 e l’8 aprile dal Centro Italiano di Sessuologia, il cui programma includeva una discussione sulle terapie psicologiche e psichiatriche volte a ‘debellare’ l’omosessualità. Alla contestazione parteciparono anche gay e lesbiche provenienti dall’Inghilterra, dalla Francia e dal Belgio, testimoniando il respiro internazionale dell’organizzazione torinese.
Questa «piccola Stonewall nostrana» segnò un momento cruciale per la visibilità del movimento omosessuale nel paese e, anche a seguito di questo evento, nel corso degli anni Settanta si diffusero su tutto il territorio italiano numerose organizzazioni impegnate nella lotta di rivendicazione e liberazione sessuale. Il Collettivo Omosessuale Orfeo, un gruppo autonomo composto prevalentemente da studenti e studentesse universitarie del nord della Toscana (dalla Versilia a Livorno), fu fondato poco più tardi in un clima locale di intensa aggressione, culminato nell’efferato delitto a colpi di pistola di un omosessuale residente a Santa Croce sull’Arno alla fine del maggio 1979. La notizia occupò le prime pagine dei giornali locali per diverso tempo, destando scalpore e richiamando l’attenzione della cittadinanza. A queste brutalità il gruppo Orfeo decise di reagire organizzando una manifestazione contro la violenza e l’omofobia, che affermasse contestualmente anche l’esistenza di omosessuali e transessuali attraverso la visibilità offerta da un evento di strada. La marcia, considerata la prima vera manifestazione italiana dell’orgoglio gay, fu anche la prima, a livello nazionale, a essere autorizzata dalla questura e patrocinata da un Comune, come confermano i documenti video (affidati in più casi alla viva voce dei protagonisti di allora) raccolti e diffusi in internet, insieme a scatti fotografici e a varie testimonianze, in occasione della celebrazione dell’evento avvenuta a Pisa a trent’anni di distanza.
Nota come ‘Pisa79’, la manifestazione fu indetta per il 24 novembre. Prima dell’avvio del corteo, che si sarebbe svolto in modo completamente pacifico intonando canti e slogan e a cui avrebbero preso parte alcune centinaia di persone, l’appuntamento venne dato in Piazza dei Cavalieri, dove i manifestanti si radunarono con striscioni e volantini, determinati a normalizzare e rivendicare la propria presenza fisica in quest’area urbana, trasformata così da luogo di rappresentanza politica e potere in uno spazio di visibilità, autodeterminazione e liberazione collettiva. Come attestano gli scatti oggi conservati nel Fondo Frassi di Palazzo Blu, i partecipanti alla marcia appartenevano a diverse realtà, movimenti e collettivi omosessuali provenienti da tutta Italia, tra cui Taranto (Collettivo Magna Frocia), Roma (Narciso. Collettivo omosessuale romano) e Bologna (Collettivo Frocialista).
‘Pisa79’ è considerato il primo Gay Pride italiano e una delle prime manifestazioni di visibilità della comunità LGBT+. Bisognerà infatti attendere fino al 1994, con il Pride di Roma, per un altro corteo di simile risonanza.


Media gallery

1990-1991
Il movimento della Pantera e le manifestazioni contro la Guerra del Golfo
Nei primi mesi del 1990 e di nuovo nel gennaio del 1991 Piazza dei Cavalieri accolse diverse manifestazioni di protesta: prima quella studentesca della cosiddetta Pantera, contraria alla proposta di Legge Ruberti, poi la mobilitazione contro la guerra in Iraq, che coinvolse anche a Pisa diverse componenti della società civile.


Alla fine del 1989 la contestazione scoppiò per prima nella città di Palermo, dove la componente studentesca universitaria in assemblea permanente decise di occupare a tempo indeterminato la Facoltà di Lettere e Filosofia, come segno di protesta nei confronti del recente progetto di riforma universitaria promosso dal ministro socialista Antonio Ruberti. La legge determinava l’introduzione di un’autonomia finanziaria per gli atenei italiani, sollecitando quindi la ricerca di collaborazioni e finanziamenti da parte di enti esterni, che prospettava, nei timori dei partecipanti alla contestazione, l’ingresso anche dei privati nell’università. Lo slogan scelto per la protesta, «la pantera siamo noi», nasceva grazie a due militanti pubblicitari che avevano suggerito come simbolo questo animale sia in continuità con le Black Panthers americane, sia come richiamo a un fatto di cui in quel momento si narrava (quasi si trattasse di un evento mitologico), ovvero l’aggirarsi di una pantera, scappata da uno zoo privato, per le campagne romane. La protesta si estese quindi in tutta Italia dal gennaio 1990 e fu subito caratterizzata da nuovi aspetti organizzativi come l’impiego del fax da parte di un vero e proprio ufficio stampa. L’obiettivo era sia la controinformazione verso l’esterno, cioè contro la censura e la narrazione della stampa tradizionale, sia l’aggiornamento all’interno stesso del movimento, perché grazie al fax i vari collettivi di tutta Italia potevano comunicare fra loro istantaneamente e condividere proposte. Un ulteriore elemento peculiare della Pantera e di rottura rispetto al passato fu l’uso della creatività e dell’ironia come codice dell’inclusione, attraverso volantini, vignette, cartelloni, video, che arrivarono persino sui mass media.
«Il vento della contestazione moltiplica i focolai di lotta», approdando anche a Pisa. Per prima la protesta coinvolse Lettere e Filosofia il 22 gennaio del 1990, quando venne votato il blocco della facoltà, per poi espandersi al resto dell’ateneo. Fu in particolare grazie agli studenti pisani di informatica che il movimento riuscì a organizzare per la prima volta una rete di posta elettronica con il nome di «Okkupanet»: l’innovativo strumento ancora più del fax permise ai (pochi) atenei in grado di utilizzarlo di accelerare la comunicazione, che non si sostituì, in ogni caso, alle forme di protesta più tradizionali.
Il 30 gennaio studentesse e studenti delle scuole superiori e delle università percorsero infatti le vie di Pisa in un corteo cittadino, con lo slogan «No alla Legge Ruperti». Punto di arrivo di queste manifestazioni fu Piazza dei Cavalieri dove, come già nelle proteste del ’68, lo scalone di accesso del Palazzo della Carovana fu adoperato per esporre cartelloni e per ricapitolare con un megafono i punti salienti della contestazione e le rivendicazioni. Nell’arco di pochi mesi la Pantera interruppe le sue azioni, a causa sia della necessità di far riprendere la normale attività degli atenei, sia per spaccature interne, dovute anche al fatto che il Governo, nella Legge Ruberti bis, aveva recepito alcune delle rivendicazioni del movimento. L’importanza di Piazza dei Cavalieri come arena di manifestazione del dissenso, d’altra parte, non cessò: il 15 gennaio 1991, oltre 5000 persone avrebbero, per altre ragioni, sfilato nuovamente per la città arrestandosi nella piazza.


Il giorno coincideva con quello dell’ultimatum dato dalle Nazioni Unite all’Iraq, che il 2 agosto 1990 aveva occupato il Kuwait. Il termine imponeva l’accettazione incondizionata delle richieste Onu, dopo una serie di risoluzioni progressivamente sempre più severe (dalle sanzioni economiche all’embargo) contro il paese guidato da Saddam Hussein per ottenere il ritiro delle truppe e la ripresa dei negoziati di pace. Oltre il 15 gennaio la coalizione internazionale sarebbe stata legittimata a intervenire in sostegno del Kuwait.
Nel frattempo, la società civile italiana si stava mobilitando: il 7 ottobre 1990 la marcia della pace Perugia-Assisi fu largamente partecipata, e ovunque vennero promosse manifestazioni contro la guerra, al grido degli slogan «niente sangue per il petrolio» o «fuori la guerra dalla storia», e invocando il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione. A Pisa venne creato un coordinamento cittadino contro la guerra, furono organizzati assemblee e scioperi. Il 13 gennaio a pochi giorni dalla scadenza, gli studenti delle scuole superiori scrivevano in un comunicato: «noi ragazzi di Pisa ci sentiamo in dovere di far conoscere il nostro dissenso per i fatti che stanno accadendo. Non essendo in grado di fare nient’altro, vogliamo rendere nota la nostra presa di posizione a favore delle persone che cercano disperatamente di risolvere questa questione internazionale. Noi non possiamo capire fino in fondo le motivazioni che spingono Saddam a volere la guerra, ma di una cosa siamo certi: che la situazione creatasi danneggerà soprattutto le persone semplici come noi».
Il clima poi si infiammò velocemente, come riportato dalla stampa locale, convinta che Pisa fosse «un’area calda», sia per «la presenza della base militare di Camp Darby a Tirrenia, delle caserme dei paracadutisti, dell’aeroporto militare e civile, [e] di un’importante stazione ferroviaria», sia soprattutto per «l’Università, con i suoi ospiti stranieri, giovani e meno giovani, anche mediorientali», tutti elementi che richiedevano l’attenzione delle forze dell’ordine «che devono tenere sotto controllo la situazione con discrezione ma anche con assiduità». La manifestazione del 15 gennaio fu ampiamente partecipata. Sfilarono per Piazza dei Cavalieri molti soggetti dal mondo dell’associazionismo cittadino ai partiti e sindacati, agli studenti universitari e medi, tutti uniti per dire «No!» alla guerra. Nelle richieste del comitato cittadino, quella del cessate il fuoco immediato si legava anche ad altre parole d’ordine del movimento per la pace, dall’autodeterminazione dei popoli del Medioriente alla smilitarizzazione del territorio.
Gli eventi mediorientali si incardinarono in una nuova fase internazionale che vedeva la fine della guerra fredda e la disgregazione dell’URSS, e in un contesto italiano che affrontava e subiva grandi trasformazioni sociali e politiche. Tra le altre, infatti, mentre stava per tramontare la lunga fase del Governo di coalizione del cosiddetto Pentapartito (Dc, Psi, Psdi, Pri, Pli), il Partito comunista aveva effettuato la «svolta della Bolognina», che aveva avviato il suo processo di scioglimento avvenuto il 3 febbraio 1991. Furono cambiamenti che ebbero un riflesso anche nel contesto periferico pisano. Qui, in particolare, a fare da sfondo e per certi versi da elemento distraente rispetto ai grandi stravolgimenti internazionali fu la messa in sicurezza della Torre di Pisa, con ricerche e interventi atti a ridurne la pendenza. La stampa locale titolava con queste parole un articolo del gennaio 1991: «Desolazione sotto la Torre. E la guerra uccide il turismo».
Media gallery

1993
Processo a Ugolino
In Piazza dei Cavalieri venne inscenato nel 1993 un processo simbolico al conte Ugolino della Gherardesca per considerare, al di là della narrazione dantesca, le responsabilità del personaggio storico nei confronti di Pisa. L’evento, promosso dal Comune, offrì al pubblico l’occasione per riflettere su come memoria storica, verità giuridica e letteratura possano divergere, stimolando una rilettura critica del passato civico.
Il 4 giugno 1993, Piazza dei Cavalieri venne scelta come suggestivo scenario per ospitare un processo simbolico al conte Ugolino della Gherardesca, condannato a morire per inedia nel 1289 insieme a due figli e due nipoti dentro la Torre della Fame. A distanza di quasi sette secoli, la città di Pisa decise di dare al conte medievale, idealmente seduto sul banco degli imputati, l’opportunità di dimostrare, davanti al Palazzo dell’Orologio ovvero proprio in prossimità del luogo del suo decesso, la propria innocenza.


L’evento, promosso dal Comune con la collaborazione del Teatro Verdi e del Comitato del Gioco del Ponte, e pubblicizzato per la città con diverse locandine, si configurò come un autentico processo, condotto secondo le procedure dell’attuale Codice penale. Con una Corte costituita da storici, storiche, giuristi, magistrati e intellettuali, in costume d’epoca, la Piazza, gremita da un numeroso pubblico, assistette per oltre due ore e mezza a una ricostruzione filologica degli eventi che portarono il conte alla prigionia. L’intento degli organizzatori era infatti quello di offrire alla cittadinanza gli strumenti per una presa di distanza critica soprattutto dall’immagine letteraria di Ugolino, sapientemente cristallizzata da Dante nella Divina Commedia, ma non senza contraddizioni con la concreta realtà storica dei fatti e soprattutto senza esplicitare le motivazioni della sua condanna eterna come traditore della patria.
Il processo, come chiarito nel suo prologo dalla voce narrante dell’Araldo – interpretato dall’attore e regista Fabrizio Primucci –, si prefisse quindi di «prendere in esame la condotta politica dell’imputato nell’arco di almeno un ventennio, con il solo intento di ristabilire la verità dei fatti». L’accusa, sostenuta dal magistrato Domenico Manzione, articolò quattro capi d’imputazione contro il conte con lo scopo di dimostrare come le sue azioni non fossero episodi isolati, bensì tasselli di un disegno politico coerente e organico, volto intenzionalmente al consolidamento del proprio potere personale a scapito della città di Pisa. Il processo, con la difesa affidata al giornalista Sergio Carlesi, si concentrò così su quattro episodi cruciali della carriera politica di Ugolino, considerati emblematici della sua condotta. I testimoni dell’accusa, Maria Luisa Ceccarelli Lemut e Mauro Ronzani, si confrontarono con quelli della difesa, Gabriella Garzella e Marco Tangheroni: tutti e tutte medievisti e docenti dell’Università di Pisa.
Dei quattro capi d’imputazione mossi contro il conte, tra i quali l’accusa di aver cercato di salvaguardare i propri territori in Sardegna a discapito degli interessi del Comune (ca. 1270-1276), quella di avere abbandonato la Battaglia della Meloria condannando Pisa alla sconfitta (1284) e quella di avere ceduto i castelli di Pontedera, Ripafratta e Viareggio ai guelfi lucchesi (1285), solo il quarto gli valse la condanna. Secondo la Corte, presieduta dall’allora magistrato di cassazione Bruno Capurso, l’unica colpa effettivamente attribuibile a Ugolino sarebbe stato infatti il presunto tradimento perpetuato nei confronti del nipote Nino Visconti, per estrometterlo dalla diarchia e consolidare la propria posizione come unico e indiscusso signore di Pisa. Sarebbe stato questo il vero tradimento di Ugolino: l’apice delle sue manovre politiche per soddisfare le proprie ambizioni personali a danno del bene della propria città. Nonostante la parziale assoluzione, alla fine il verdetto mitigò l’immagine del conte tramandata dalla tradizione, ma di fatto senza dissiparne completamente le ombre.
I contenuti degli interventi pronunciati durante l’udienza, tra cui le ricostruzioni dell’accusa e della difesa, furono raccolti nella pubblicazione Processo a Ugolino, curata dal Comune di Pisa, che documenta in dettaglio l’impianto argomentativo adottato dalle parti, restituendo la complessità storica, politica e simbolica attribuita alla figura del conte nel dibattitto contemporaneo.
Media gallery

2012
Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso
Durante il pomeriggio del 16 dicembre 2012, al centro di Piazza dei Cavalieri, prese forma, con la partecipazione della cittadinanza pisana e della comunità degli allievi della Scuola Normale, l’istallazione de 'Il Terzo Paradiso', di Michelangelo Pistoletto.

L’evento si inseriva nell’ambito di una serie di iniziative organizzate in occasione della riapertura di Piazza dei Cavalieri dopo mesi di lavori destinati alla sua nuova pavimentazione in pietra arenaria. Il progetto dell’opera, affidato a uno degli artisti italiani più influenti della seconda metà del Novecento, fu promosso dal Comune di Pisa, dalla Scuola Normale e dal Centro Luigi Pecci di Prato, in collaborazione con il Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea e con Cittadellarte, il centro di ricerca fondato a Biella nel 1998 dallo stesso Pistoletto. Se da un lato, quindi, l’iniziativa segnò il ritorno ufficiale della Piazza alla vita quotidiana della comunità cittadina e studentesca, dall’altro, essa coincise anche con l’inizio di una stagione di rinnovata apertura, da parte della Normale, verso il mondo dell’arte contemporanea, proseguito nel corso degli anni successivi attraverso una collaborazione sempre più stretta con il Centro Pecci, di cui proprio da quell’anno iniziarono a essere allestite periodicamente opere negli spazi del Palazzo della Carovana.
Il Terzo Paradiso è un simbolo concepito da Pistoletto all’inizio degli anni Duemila come icona di un nuovo possibile equilibrio tra uomo e pianeta. Esso si compone di tre cerchi concatenati che richiamano il segno matematico dell’infinito, con l’aggiunta di un elemento centrale più grande. I due cerchi laterali rappresentano, da una parte, lo stato di natura primordiale (il «primo Paradiso»), e dall’altra il mondo della scienza, della tecnologia e dell’artificio (il «secondo Paradiso»), alla base di importanti benefici per l’uomo contemporaneo ma anche di un violento consumo delle risorse del nostro ecosistema. Il cerchio centrale, invece, simboleggia appunto il «terzo Paradiso»: la speranza nell’avvento di un’era in cui questi due mondi, apparentemente contrapposti, possano finalmente coesistere attraverso una equilibrata connessione tra natura e tecnica, fondata su una responsabilità collettiva tesa verso una forma di progresso sostenibile. «Terzo Paradiso significa il passaggio a uno stadio inedito della civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza», scriveva Pistoletto nel suo manifesto Che cos’è il Terzo Paradiso? (2003), «è la compenetrazione fra i cerchi opposti e rappresenta il grembo generativo della nuova umanità».
A partire da quel momento, in effetti, Il Terzo Paradiso avrebbe rappresentato per molti anni la principale direttrice del lavoro dell’artista. Il simbolo dei tre cerchi sarebbe diventato l’icona di una sintesi ideale tra progresso e sostenibilità: un invito alla riflessione sul rapporto tra natura, tecnologia e società riproposto in numerosi contesti urbani e museali (tra gli altri, le Terme di Caracalla a Roma, Piazza della Signoria a Firenze, o ancora il Bosco di San Francesco ad Assisi), senza tuttavia mai rinunciare all’unicità delle singole istallazioni, spesso realizzate con il coinvolgimento attivo delle comunità a cui erano rivolte. Come ribadito dallo stesso Pistoletto durante un incontro organizzato nel Palazzo della Carovana alla vigilia della sua istallazione pisana, proprio questo processo di partecipazione collettiva all’interno di uno spazio pubblico costituiva il vero fattore determinante affinché la propria «oper-azione» potesse farsi veicolo di una riflessione realmente condivisa.
Nel caso di Piazza dei Cavalieri, Il Terzo Paradiso venne realizzato attraverso l’accostamento di centinaia di libri che studenti e cittadini erano stati invitati a portare con sé in piazza. Si trattava ovviamente di una scelta dal preciso valore simbolico: volta a porre l’accento sullo stretto legame tra vita universitaria e spazio urbano, oltre che sulla centralità del concetto di «studio» nella costruzione di un pensiero critico orientato verso una società migliore, più equa e sostenibile. A questo si aggiungeva inoltre la volontà di offrire un’immagine chiara della contaminazione tra saperi diversi, scientifici ed umanistici, proponendo insomma un approccio interdisciplinare fondato sul libero incontro di conoscenze come unico mezzo per rispondere alle sfide più complesse della contemporaneità.


Pochi giorni più tardi, il 21 dicembre 2012, Pistoletto avrebbe indetto il primo Rebirth-day: una sorta di «festa mondiale della rinascita», volontariamente fissata in corrispondenza con la data che, secondo la cultura popolare e cinematografica dei primi anni Duemila, avrebbe dovuto coincidere invece con la fine del mondo prevista dai calendari dell’antica civiltà Maya. In quella occasione, l’artista e il suo staff coordinarono centinaia di eventi e iniziative organizzate in tutto il mondo (performance, concerti, flash-mob, installazioni), volte a celebrare la speranza in un rinnovamento profondo del sistema delle relazioni umane. Una ricca documentazione di questa grande opera collettiva e geograficamente diffusa sarebbe stata poi presentata da Pistoletto in occasione di una sua mostra personale: Année 1. Le paradis sur terre, inaugurata la primavera successiva al Musée du Louvre a Parigi.
Media gallery

2015-2025
Spettacoli e cultura in Piazza
Piazza dei Cavalieri negli ultimi anni ha rappresentato per la città di Pisa un luogo di aggregazione spontanea giovanile e di fruizione culturale. Movimenti di cultura dal basso, spettacoli a pagamento, intrattenimenti di alta divulgazione scientifica ad accesso gratuito si sono contesi il ‘possesso’ di quest’area urbana, che, coinvolgendo un pubblico stratificato, ha riaffermato anche in questo modo la sua centralità nella vita cittadina e universitaria.
Geograficamente posta all’interno del centro storico e nella direttrice che collega gli epicentri delle tre università della città, Piazza dei Cavalieri nelle ore serali e notturne soprattutto nell’ultimo decennio si è configurata di fatto come uno spazio attrattivo all’aria aperta per la popolazione studentesca: un luogo di aggregazione spontanea di gruppi e persone, dove realtà, culture, provenienze diverse hanno iniziato a incontrarsi e mescolarsi, promuovendo una ‘cultura dal basso’ attraverso la musica di strada con chitarre, tamburi, tamburelli e giochi. Per quanto alternativa e spontanea, questa fruizione della piazza non è stata priva di criticità, di problemi di ordine pubblico e di disturbo della quiete. La difficile conciliabilità di questa fruizione con la funzione abitativa dell’area circostante, nonché con vincoli di tutela imposti all’area storica, ha generato un dibattito pubblico che ciclicamente è tornato in auge nella stampa locale condannando il fenomeno come ‘malamovida’.
In risposta a questo fenomeno il Comune di Pisa ha sia intensificato progressivamente la vigilanza sulla piazza, sia promosso una serie di iniziative culturali più istituzionali: grandi eventi, come la rassegna Summer Knights ogni settembre dal 2019, con musica dal vivo di qualità, che prevede però la chiusura dell’area, accessibile in queste occasioni soltanto a pagamento. La proposta offerta alla cittadinanza di iniziative culturali in piazza non è d’altra parte una novità recente. Già nel 1997 Andrea Bocelli aveva scelto il teatro urbano rinnovato da Giorgio Vasari come luogo in cui mettere in scena il concerto di successo internazionale A Night in Tuscany, nel corso del quale in una serie di duetti veniva presentata una mescolanza di generi: dall’opera alla musica pop. Nel decennio seguente si sono esibiti altri artisti di grande fama, tra i quali nell’estate del 2003 Lou Reed e Franco Battiato, non senza però innescare successivamente un dibattito tra il Comune, la Soprintendenza e uno degli enti organizzatori di questi eventi, il Metarock, sull’uso di uno spazio storico per i grandi concerti, soprattutto in rapporto al problema dell’impatto acustico.
A ‘contendersi’ Piazza dei Cavalieri è intervenuta ultimamente anche la Scuola Normale, alla quale spetta il merito di aver promosso attività culturali secondo diverse declinazioni, sempre a titolo gratuito: il ciclo Arte e scienza si incontrano in piazza che, avviato nel 2017 e concepito come conferenze serali su temi culturali con accompagnamento di musiche e letture, ha visto il coinvolgimento di personaggi del mondo accademico e figure pubbliche della divulgazione scientifica e del mondo dell’arte, tra cui, in uno degli appuntamenti del primo anno di sperimentazione, il compositore Nicola Piovani; una rassegna cinematografica estiva con proiezioni di film all’interno di palinsesti tematici, precedute da presentazioni e seguite da dibattiti, grazie alla collaborazione con il Cineclub Arsenale; e infine anche il Festival of Academic Theatre, ideato dal gruppo teatrale della Normale in rete con altre compagnie universitarie.
Media gallery

2019
Riprese della serie TV ‘L’amica geniale’
Nell’autunno del 2019 si sono svolte a Pisa parte delle riprese per la serie televisiva 'L’amica geniale', basata sull’omonimo romanzo di Elena Ferrante, nel corso delle quali Piazza dei Cavalieri e il Palazzo della Carovana sono state riportate alla vitalità degli anni Sessanta.
Tra il settembre e l’ottobre del 2019 si sono svolte a Pisa parte delle riprese per la seconda stagione della serie televisiva L’amica geniale, basata sul secondo romanzo dell’omonima tetralogia di Elena Ferrante: Storia del nuovo cognome (2012), con sceneggiatura a firma di Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, coordinati dalla stessa Ferrante. La serie TV, prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment, in collaborazione con HBO e Rai Fiction, aveva riscosso già con la prima stagione un notevole successo, anche a livello internazionale. La regia della seconda era stata quindi affidata nuovamente a Saverio Costanzo (ad eccezione di due puntate: Il bacio e Il tradimento, girate invece da Alice Rohrwacher).
In Storia del nuovo cognome, il percorso di crescita di una delle due protagoniste, Elena (Lenù), ha un importante momento di svolta. La ragazza, nell’estate del 1965, vince infatti il concorso di ammissione alla Scuola Normale Superiore, trasferendosi a Pisa per frequentare l’università. Il trasferimento rappresenta un cambiamento decisivo nella vita della giovane, che ha così l’occasione di lasciare il rione Luzzatti di Napoli per immergersi nel mondo accademico e intellettuale della città toscana. Pisa diventa quindi lo sfondo dei suoi anni universitari, dei suoi progetti e dei suoi amori giovanili, ma soprattutto delle prime esperienze lontane dall’amica di sempre, Lila.
Uno degli aspetti più interessanti delle riprese pisane è stato il lavoro condotto dallo scenografo Gianfranco Basili insieme al proprio staff, il cui compito è stato innanzitutto quello di riportare indietro nel tempo, fino agli anni Sessanta, alcuni angoli della città, oltre che numerosi ambienti del Palazzo della Carovana. Se nel caso del rione Luzzatti, infatti, la produzione aveva dovuto ricostruire quasi integralmente sul set le strade e i palazzi del quartiere dove Lila e Lenù erano cresciute, servendosi anche di significative integrazioni realizzate in grafica digitale, nel caso di Pisa, invece, lo scenografo si è trovato a misurarsi direttamente con i luoghi della città toscana, attraverso una serie di interventi assai più circoscritti, finalizzati di volta in volta a restituire a questi ambienti il loro aspetto di circa sessanta anni prima.
La collaborazione della Normale, da questo punto di vista, ha svolto un ruolo assolutamente determinante. Grazie alla possibilità di accedere a documenti e fotografie dell’epoca, infatti, Basili e il suo team hanno avuto modo di trarre alcuni spunti importanti per il loro lavoro di ricostruzione, riuscendo a cogliere con grande efficacia l’atmosfera dell’ateneo pisano all’epoca dei fatti raccontati dal romanzo. Lo studio documentario è stato quindi un punto di partenza imprescindibile in vista delle scelte di scenografia e dei costumi, con un’attenzione particolare riservata all’arredamento, al vestiario degli studenti e ai luoghi della loro vita quotidiana, al centro soprattutto delle ultime due puntate della stagione: I fantasmi e La fata blu.
Alcuni ambienti di Palazzo della Carovana sono stati ovviamente modificati in base alle esigenze narrative. È stato il caso di una stanza del terzo piano, oggi destinata agli uffici del personale, riportata per l’occasione alla sua funzione originaria di camera di collegio, dove Elena trascorre la sua ultima notte insieme a Franco Mari, un compagno di università con il quale ha una relazione durante i suoi primi anni pisani. Lo stesso vale per i corridoi del primo piano, il grande scalone che conduce al terzo, e ancora l’Aula Pasquali, predisposta per ospitare la scena in cui Franco, al termine di un esame di letteratura italiana, decide di rinunciare al proprio posto da allievo e dunque alla borsa di studio assicuratagli dalla Normale. Anche la Sala del Ballatoio, infine, oggi sede dell’archivio della Scuola, è stata in parte riallestita e riportata alla sua funzione originaria: quella di biblioteca e sala studio.
Non sempre, certo, è stato possibile allestire il set nei luoghi effettivamente descritti dalla Ferrante. Gli spazi del Collegio Timpano, ad esempio, dove Elena alloggia durante i suoi anni universitari, sono stati ricostruiti da Basili all’interno del Royal Victoria Hotel, situato sul Lungarno Pacinotti a poche centinaia di metri dal vero collegio (ancora oggi destinato a ospitare gli studenti della Normale, ma completamente ristrutturato nel corso degli anni e ormai molto distante dall’aspetto dell’epoca). L’effettiva vicinanza dell’hotel al collegio della Normale ha consentito poi di mantenere anche uno stretto legame visivo e concettuale con i luoghi descritti dal romanzo.
Un lavoro ancora più impegnativo, inoltre, ha riguardato gli interventi di adattamento degli spazi all’aperto: i vicoli, i negozi, i tavoli dei caffè ai lati delle strade, i lungarni dove all’inizio della settima puntata sfila un grande corteo di operai. Piazza dei Cavalieri, in particolare, ormai da decenni chiusa al traffico urbano, è stata virtualmente riaperta alla vita brulicante degli anni Sessanta grazie all’impiego di lambrette, auto d’epoca parcheggiate di fronte al Palazzo della Carovana, oltre che di decine di comparse necessarie a restituire l’atmosfera vivace di una piazza che, oggi come allora, costituisce il vero cuore della vita universitaria pisana.
Nel corso delle settimane di riprese, infine, l’attrice Margherita Mazzucco, interprete del personaggio di Elena, è stata seguita da vicino da alcuni allievi della Normale, che l’hanno aiutata a comprendere meglio la realtà quotidiana degli studenti dell’ateneo, organizzando anche alcune lezioni private affinché la ragazza, allora diciassettenne, non rimanesse indietro con i suoi impegni scolastici. La tappa pisana della produzione de L’amica geniale. Storia del nuovo cognome ha rappresentato insomma un esempio virtuoso di sinergia tra un’istituzione universitaria e una produzione televisiva, tra ricerca storica e creatività scenografica. Grazie all’apertura degli spazi della Scuola Normale e all’accurato lavoro di Basili, la città di Pisa è diventata a sua volta una protagonista silenziosa della serie televisiva, contribuendo attivamente ad arricchire il racconto visivo di Elena Ferrante e Saverio Costanzo.
Media gallery

Newsletter
Resta connesso con noi
Iscriviti alla newsletter di Piazza dei Cavalieri
e resta aggiornato sui progressi e sulle novità del progetto.